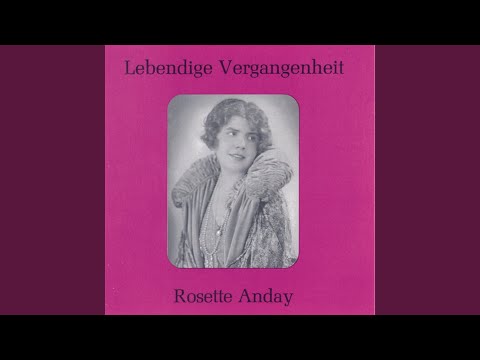L’English National Opera propone una nuova produzione dell’Orfeo gluckiano, anzi dell’Orphée, dal momento che viene offerta la versione francese del titolo, e più esattamente l’adattamento che Berlioz predispose nel 1859 per il Théâtre Lyrique, protagonista la divina Viardot. La scelta lascia perplessi. E non certo per il fatto che il libretto sia stato tradotto in inglese, com’è del resto prassi nel secondo teatro della capitale britannica. La decisione di allestire una determinata versione di un titolo come questo, che ne prevede di differenti e per giunta stratificate (è il caso della traduzione italiana dell’adattamento berlioziano, che fra aggiunte e tagli ha avuto preponderante diffusione almeno sino agli anni Settanta del secolo scorso), dovrebbe infatti dipendere in primo luogo da una scrupolosa analisi delle caratteristiche del cantante (mezzosoprano ovvero tenore) cui si affida il ruolo protagonistico e, in seconda battuta, dalla disponibilità di un corpo di ballo, che possa rendere giustizia ai numeri coreografici, presenti, è vero, in tutte le versioni, ma assai più consistenti nella revisione parigina del 1774. Per essere più chiari, proporre la versione Berlioz per eseguire “Amour, viens rendre à mon âme” senza la grandiosa cadenza conclusiva (opera del suddetto Berlioz, Saint-Saëns e madame Viardot) e sopprimere il coro “Le Dieu de Paphos”, tratto da “Echo et Narcisse” e posto in chiusura dell’opera in sostituzione del divertissement danzato, significa proporre una versione mutila, filologicamente non meno discutibile del vilipeso Orfeo di tradizione. La perplessità si sostanzia vieppiù quando si consideri che, nel caso londinese, si disponeva (almeno sulla carta) di una compagnia di danza e soprattutto di un regista/coreografo di consolidata fama, circostanza che avrebbe dovuto orientare piuttosto verso la versione viennese (volendo comunque affidare il protagonista a una voce femminile). Peraltro lo spettacolo di Wayne McGregor si anima e brilla letteralmente di luce propria esclusivamente nel balletto, che apre la scena dei Campi Elisi (atto terzo della versione berlioziana): in questi dieci minuti scarsi l’eleganza del gesto coreutico asseconda mirabilmente la partitura, assai più di quanto faccia la direzione musicale di Harry Bicket, assai slavata anche in un punto in cui l’elemento elegiaco risulta preponderante (facile immaginare che cosa possa avvenire nella scena delle Furie e più ancora nel sofferto confronto tra i coniugi). Per il resto, lo spettacolo concentra tutte le idee nell’ouverture, eseguita a sipario aperto e utilizzata quale stilizzato prologo: al posto del morso del serpente, l’ago con cui viene eseguito un prelievo di sangue, rivelatore di una malattia che in un lampo conduce Euridice alla tomba. Quel che segue non ha, purtroppo, la stessa icastica compattezza e si ha quindi l’impressione di assistere per un paio d’ore ai medesimi gesti, stilizzati e anodini, finché la vicenda si conclude con l’apparizione di un doppio “danzante” di Euridice (un secondo Orfeo, ballerino, era entrato in scena dal secondo atto) e con la riproposizione dell’immagine sepolcrale che aveva aperto la vicenda, a suggerire che il viaggio ultraterreno del cantore non sia stato che un sogno, al termine del quale l’eroe deve accettare la scomparsa della moglie. Tutte cose già viste, e con maggiore pregnanza, ad esempio nell’Orfeo di Pina Bausch, esempio ben altrimenti efficace di come opera e danza possano fondersi e confondersi, dando vita a uno spettacolo davvero innovativo e geniale. Quanto al canto, siamo nell’ambito, consueto per l’ENO, delle buone intenzioni e dei risultati interlocutori: Alice Coote è un Orfeo limitato in alto e soprattutto in basso, nonostante maldestri tentativi di “affondo” (un gelido silenzio del peraltro numeroso pubblico accoglie il suo “J’ai perdu mon Euridice”), Sarah Tynan risulta più querula che malinconica o disperata e insomma la sola Soraya Mafi rende giustizia al personaggio di Amore, cantato con una grazia che non esclude (a differenza di quanto avviene per le altre componenti dello spettacolo) l’incisività.
L’English National Opera propone una nuova produzione dell’Orfeo gluckiano, anzi dell’Orphée, dal momento che viene offerta la versione francese del titolo, e più esattamente l’adattamento che Berlioz predispose nel 1859 per il Théâtre Lyrique, protagonista la divina Viardot. La scelta lascia perplessi. E non certo per il fatto che il libretto sia stato tradotto in inglese, com’è del resto prassi nel secondo teatro della capitale britannica. La decisione di allestire una determinata versione di un titolo come questo, che ne prevede di differenti e per giunta stratificate (è il caso della traduzione italiana dell’adattamento berlioziano, che fra aggiunte e tagli ha avuto preponderante diffusione almeno sino agli anni Settanta del secolo scorso), dovrebbe infatti dipendere in primo luogo da una scrupolosa analisi delle caratteristiche del cantante (mezzosoprano ovvero tenore) cui si affida il ruolo protagonistico e, in seconda battuta, dalla disponibilità di un corpo di ballo, che possa rendere giustizia ai numeri coreografici, presenti, è vero, in tutte le versioni, ma assai più consistenti nella revisione parigina del 1774. Per essere più chiari, proporre la versione Berlioz per eseguire “Amour, viens rendre à mon âme” senza la grandiosa cadenza conclusiva (opera del suddetto Berlioz, Saint-Saëns e madame Viardot) e sopprimere il coro “Le Dieu de Paphos”, tratto da “Echo et Narcisse” e posto in chiusura dell’opera in sostituzione del divertissement danzato, significa proporre una versione mutila, filologicamente non meno discutibile del vilipeso Orfeo di tradizione. La perplessità si sostanzia vieppiù quando si consideri che, nel caso londinese, si disponeva (almeno sulla carta) di una compagnia di danza e soprattutto di un regista/coreografo di consolidata fama, circostanza che avrebbe dovuto orientare piuttosto verso la versione viennese (volendo comunque affidare il protagonista a una voce femminile). Peraltro lo spettacolo di Wayne McGregor si anima e brilla letteralmente di luce propria esclusivamente nel balletto, che apre la scena dei Campi Elisi (atto terzo della versione berlioziana): in questi dieci minuti scarsi l’eleganza del gesto coreutico asseconda mirabilmente la partitura, assai più di quanto faccia la direzione musicale di Harry Bicket, assai slavata anche in un punto in cui l’elemento elegiaco risulta preponderante (facile immaginare che cosa possa avvenire nella scena delle Furie e più ancora nel sofferto confronto tra i coniugi). Per il resto, lo spettacolo concentra tutte le idee nell’ouverture, eseguita a sipario aperto e utilizzata quale stilizzato prologo: al posto del morso del serpente, l’ago con cui viene eseguito un prelievo di sangue, rivelatore di una malattia che in un lampo conduce Euridice alla tomba. Quel che segue non ha, purtroppo, la stessa icastica compattezza e si ha quindi l’impressione di assistere per un paio d’ore ai medesimi gesti, stilizzati e anodini, finché la vicenda si conclude con l’apparizione di un doppio “danzante” di Euridice (un secondo Orfeo, ballerino, era entrato in scena dal secondo atto) e con la riproposizione dell’immagine sepolcrale che aveva aperto la vicenda, a suggerire che il viaggio ultraterreno del cantore non sia stato che un sogno, al termine del quale l’eroe deve accettare la scomparsa della moglie. Tutte cose già viste, e con maggiore pregnanza, ad esempio nell’Orfeo di Pina Bausch, esempio ben altrimenti efficace di come opera e danza possano fondersi e confondersi, dando vita a uno spettacolo davvero innovativo e geniale. Quanto al canto, siamo nell’ambito, consueto per l’ENO, delle buone intenzioni e dei risultati interlocutori: Alice Coote è un Orfeo limitato in alto e soprattutto in basso, nonostante maldestri tentativi di “affondo” (un gelido silenzio del peraltro numeroso pubblico accoglie il suo “J’ai perdu mon Euridice”), Sarah Tynan risulta più querula che malinconica o disperata e insomma la sola Soraya Mafi rende giustizia al personaggio di Amore, cantato con una grazia che non esclude (a differenza di quanto avviene per le altre componenti dello spettacolo) l’incisività.