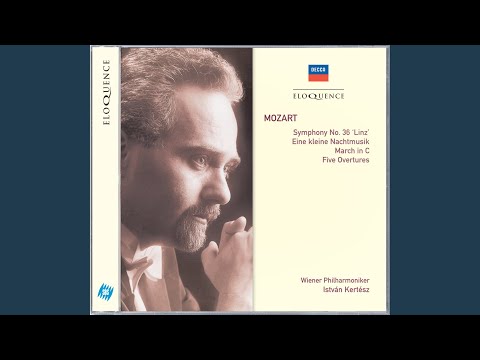E’ un mondo a pezzi quello della Clemenza “secondo” Willy Decker, che nel 1997 firmò l’allestimento per l’Opéra de Paris, ora ripreso al Teatro del Maggio fiorentino (senza che il demiurgo abbia avuto parte in questa riproposta). Domina la spoglia scena un enorme blocco di marmo che poco a poco, con il favore di un siparietto da avanspettacolo che cala in prossimità della fine di ogni quadro, assume la forma di una testa umana, ovviamente quella di Tito, destinato a diventare pirandellianamente statua di se stesso, prigioniero del proprio status di “vera delizia de’ mortali”. In questa trovata sta tutta la regia di uno spettacolo scombiccherato, che non è teatro di regia né un antidoto alla staticità del dramma metastasiano, bensì un’accozzaglia di gag (Vitellia come dominatrice sadomaso – sai che novità – a cui Servilia ruba stola e guanti, per poi deriderla mentre Annio e Sesto duettano, o ancora Vitellia che, durante la grande aria di Sesto al primo atto, sbuffa e passeggia nervosamente su e giù per la scena), trovatine (il coro uscito da qualche disegno di gusto goyesco, che deride e quasi lincia la povera Berenice e comunque circonda e opprime gli esponenti della corte imperiale, o ancora l’attentato risolto “a vista”) che vorrebbero essere pennellate grottesche e risultano solo maldestri tentativi di “fare ammuina”, sperando in questo modo di compensare quelle che vengono evidentemente avvertite quali gravi carenze dell’opera. In realtà, come spesso capita, basterebbe che i cantanti non fossero lasciati soli (o per meglio dire, abbandonati a se stessi) nel tentativo di scandire i recitativi (meravigliosi anche semplicemente sotto il profilo della poesia, ché pochi versi sono musicalmente perfetti come quelli del poeta cesareo), restituire il carattere delle arie e dei pezzi concertati. Tutto questo avviene solo in minima parte e quasi esclusivamente in forza dell’impegno dei singoli. Poco importa, alla fine, che la scena conclusiva sia ben gestita sotto il profilo dei rapporti fra i personaggi (Sesto respinge con amarezza l’avvicinamento tentato da Vitellia, rendendo palese l’irrimediabile solitudine dei tre personaggi di punta e l’assenza di qualsiasi happy end), perché è preceduta, letteralmente, da due ore e mezza di concerto in costume, per giunta con abiti bruttini e, per l’appunto, molte, troppe amenità che dimostrano, oltre ogni possibile dichiarazione d’intenti, come Mozart e il Settecento siano ancora irriducibilmente ridotti alla sfera dell’opera comica, per non dire della farsa. A parziale compensazione del deficitario spettacolo visivo abbiamo una direzione musicale tutto sommato convincente e almeno un paio di prove interessanti (con alcuni limiti) sotto il profilo vocale. Federico Maria Sardelli non si ripete ai livelli dell’Alceste della stagione scorsa ma propone comunque una lettura composta senza essere rigida, vivace eppure priva di inutili accelerazioni, cristallina negli impasti sonori senza che venga per sistema evocata l’opera di mezzo carattere (solo nel finale primo si avverte la mancanza di un più incisivo accento tragico). In più di un’occasione (terzetto “Se al volto mai ti senti” e la successiva aria di Tito con il coro) emergono con straordinaria chiarezza i legami della partitura con l’ingannevole, “fiabesca” semplicità del Flauto magico. L’orchestra (soprattutto nella sezione dei fiati) asseconda il direttore con precisione e finezza; non così il coro, che specie nel primo atto risulta in sistematico décalage rispetto alla buca. Antonio Poli è un Tito di buona voce, sicura presenza scenica e salda tenuta musicale (al netto di occasionali portamenti, che tendono a presentarsi in zona di passaggio e ostacolano la fluidità della coloratura), capace nel complesso di incarnare un protagonista al tempo stesso autorevole e tenero (anche se la regia tende a presentarlo, più che altro, come una vittima delle circostanze, nonché di tutti gli altri personaggi). Roberta Mameli ha ottime intenzioni sotto il profilo espressivo, scende con sufficiente omogeneità (tenuto conto della sua natura vocale, che non è certo quella del soprano drammatico richiesto dalla parte di Vitellia) e, soprattutto nella prima aria, regge senza fatica il tempo piuttosto lento staccato dal direttore, conferendo a “Deh se piacer mi vuoi” tutto il simulato patetismo e il velenoso sarcasmo del caso. Purtroppo, nella sezione finale della medesima aria iniziano i problemi, che si manifestano in primo luogo nella regione medio acuta, con suoni fissi e spesso stonati. Inoltre, man mano che la recita prosegue le risorse della cantante sembrano progressivamente venir meno, tanto che il rondò “Non più di fiori”, condotto all’insegna della prudenza e del risparmio (anche sotto il profilo del volume), passa semplicemente inosservato. Decisamente peggiore il resto del comparto femminile: Giuseppina Bridelli canta di strozza, con poca punta sugli acuti e una gestione faticosissima del canto di agilità, l’Annio di Loriana Castellano imita in tutto e per tutto la collega e, per giunta, sembra conoscere poco e male i recitativi (tutte le “papere” sono impietosamente evidenziate dai sovratitoli). Un filo meglio Silvia Frigato quale Servilia, ma la voce è davvero minuscola e l’espressione più adatta a una Zerlina di provincia che non alla giovane patrizia. Completa la compagnia il Publio corretto (e nulla più) di Adriano Gramigni.
E’ un mondo a pezzi quello della Clemenza “secondo” Willy Decker, che nel 1997 firmò l’allestimento per l’Opéra de Paris, ora ripreso al Teatro del Maggio fiorentino (senza che il demiurgo abbia avuto parte in questa riproposta). Domina la spoglia scena un enorme blocco di marmo che poco a poco, con il favore di un siparietto da avanspettacolo che cala in prossimità della fine di ogni quadro, assume la forma di una testa umana, ovviamente quella di Tito, destinato a diventare pirandellianamente statua di se stesso, prigioniero del proprio status di “vera delizia de’ mortali”. In questa trovata sta tutta la regia di uno spettacolo scombiccherato, che non è teatro di regia né un antidoto alla staticità del dramma metastasiano, bensì un’accozzaglia di gag (Vitellia come dominatrice sadomaso – sai che novità – a cui Servilia ruba stola e guanti, per poi deriderla mentre Annio e Sesto duettano, o ancora Vitellia che, durante la grande aria di Sesto al primo atto, sbuffa e passeggia nervosamente su e giù per la scena), trovatine (il coro uscito da qualche disegno di gusto goyesco, che deride e quasi lincia la povera Berenice e comunque circonda e opprime gli esponenti della corte imperiale, o ancora l’attentato risolto “a vista”) che vorrebbero essere pennellate grottesche e risultano solo maldestri tentativi di “fare ammuina”, sperando in questo modo di compensare quelle che vengono evidentemente avvertite quali gravi carenze dell’opera. In realtà, come spesso capita, basterebbe che i cantanti non fossero lasciati soli (o per meglio dire, abbandonati a se stessi) nel tentativo di scandire i recitativi (meravigliosi anche semplicemente sotto il profilo della poesia, ché pochi versi sono musicalmente perfetti come quelli del poeta cesareo), restituire il carattere delle arie e dei pezzi concertati. Tutto questo avviene solo in minima parte e quasi esclusivamente in forza dell’impegno dei singoli. Poco importa, alla fine, che la scena conclusiva sia ben gestita sotto il profilo dei rapporti fra i personaggi (Sesto respinge con amarezza l’avvicinamento tentato da Vitellia, rendendo palese l’irrimediabile solitudine dei tre personaggi di punta e l’assenza di qualsiasi happy end), perché è preceduta, letteralmente, da due ore e mezza di concerto in costume, per giunta con abiti bruttini e, per l’appunto, molte, troppe amenità che dimostrano, oltre ogni possibile dichiarazione d’intenti, come Mozart e il Settecento siano ancora irriducibilmente ridotti alla sfera dell’opera comica, per non dire della farsa. A parziale compensazione del deficitario spettacolo visivo abbiamo una direzione musicale tutto sommato convincente e almeno un paio di prove interessanti (con alcuni limiti) sotto il profilo vocale. Federico Maria Sardelli non si ripete ai livelli dell’Alceste della stagione scorsa ma propone comunque una lettura composta senza essere rigida, vivace eppure priva di inutili accelerazioni, cristallina negli impasti sonori senza che venga per sistema evocata l’opera di mezzo carattere (solo nel finale primo si avverte la mancanza di un più incisivo accento tragico). In più di un’occasione (terzetto “Se al volto mai ti senti” e la successiva aria di Tito con il coro) emergono con straordinaria chiarezza i legami della partitura con l’ingannevole, “fiabesca” semplicità del Flauto magico. L’orchestra (soprattutto nella sezione dei fiati) asseconda il direttore con precisione e finezza; non così il coro, che specie nel primo atto risulta in sistematico décalage rispetto alla buca. Antonio Poli è un Tito di buona voce, sicura presenza scenica e salda tenuta musicale (al netto di occasionali portamenti, che tendono a presentarsi in zona di passaggio e ostacolano la fluidità della coloratura), capace nel complesso di incarnare un protagonista al tempo stesso autorevole e tenero (anche se la regia tende a presentarlo, più che altro, come una vittima delle circostanze, nonché di tutti gli altri personaggi). Roberta Mameli ha ottime intenzioni sotto il profilo espressivo, scende con sufficiente omogeneità (tenuto conto della sua natura vocale, che non è certo quella del soprano drammatico richiesto dalla parte di Vitellia) e, soprattutto nella prima aria, regge senza fatica il tempo piuttosto lento staccato dal direttore, conferendo a “Deh se piacer mi vuoi” tutto il simulato patetismo e il velenoso sarcasmo del caso. Purtroppo, nella sezione finale della medesima aria iniziano i problemi, che si manifestano in primo luogo nella regione medio acuta, con suoni fissi e spesso stonati. Inoltre, man mano che la recita prosegue le risorse della cantante sembrano progressivamente venir meno, tanto che il rondò “Non più di fiori”, condotto all’insegna della prudenza e del risparmio (anche sotto il profilo del volume), passa semplicemente inosservato. Decisamente peggiore il resto del comparto femminile: Giuseppina Bridelli canta di strozza, con poca punta sugli acuti e una gestione faticosissima del canto di agilità, l’Annio di Loriana Castellano imita in tutto e per tutto la collega e, per giunta, sembra conoscere poco e male i recitativi (tutte le “papere” sono impietosamente evidenziate dai sovratitoli). Un filo meglio Silvia Frigato quale Servilia, ma la voce è davvero minuscola e l’espressione più adatta a una Zerlina di provincia che non alla giovane patrizia. Completa la compagnia il Publio corretto (e nulla più) di Adriano Gramigni.