 La rete non perdona, e se in passato i responsabili del sito del Teatro alla Scala e della pagina Facebook ci hanno regalato perle,
La rete non perdona, e se in passato i responsabili del sito del Teatro alla Scala e della pagina Facebook ci hanno regalato perle,
non solo per le dabbenaggini spese per presentare in poche righe un’opera, ma soprattutto per strafalcioni puerili come il recentissimo “Elisir d’amore” attribuito a Giacomo Puccini, ecco arrivare adesso la notizia della riscoperta dell’opera “Wozzeck”, o meglio “Vozzecchio”, melodramma in tre atti di Gioacchino Rossini, in una smagliante edizione critica curata dalla Fondazione Rossini di Pesaro e Casa Ricordi. Stavolta non pubblicata sul sito, ma direttamente su alcune locandine promozionali. Allora perché non giocare? Abbiamo pensato ad una locandina nella quale proporre un cast ideale che potremmo trovare sulle tavole del Piermarini, ma anche in quel ROF, che tante volte ha contribuito a riscoprire le opere del pesarese. Immaginiamo l’ouverture, dalla “Gazza ladra” magari, il rondò finale (lieto, ovvio) di Maria sulle note di “Tanti affetti in tal momento”, che sancisce la riconciliazione con il marito cornuto, e poi il solito profluvio di arie da sorbetto e da baule ed i soliti duetti e terzetti autoimprestati dai vari “Ciro in Babilonia”, “Aureliano in Palmira”, “Elisabetta, regina d’Inghilterra”, etc.
E se “Elisir” è opera pucciniana, e “Wozzeck” rossiniana, allora potremmo pensare, ragionando come i signori di cui sopra, che il recente “Otello” fosse opera di Berg ed il clamoroso tonfo con il quale è stato salutato alla fine, lo si potrebbe spiegare con l’ignoranza e la poca lungimiranza da parte del pubblico di fronte alla musica ed al canto tipici del ‘900 espressionista tedesco.
Basta celiar e arriviamo alla cronaca della serata scaligera trascorsa in compagnia di “Wozzeck” e di Berg.
 Avrebbe dovuto rappresentare lo spettacolo di chiusura della, deludente e trascurabile,“stagione nella stagione” dedicata all’EXPO, quel “Finale di partita” (Fin de partie – Endgame) composto dal maestro Gyorgy Kurtag e tratto dall’omonima opera teatrale del Vate del Teatro dell’assurdo, il Premio Nobel Samuel Beckett, poi posticipata già due volte a causa dei numerosi problemi personali e di salute del compositore che hanno ritardato suo malgrado il completamento della partitura.
Avrebbe dovuto rappresentare lo spettacolo di chiusura della, deludente e trascurabile,“stagione nella stagione” dedicata all’EXPO, quel “Finale di partita” (Fin de partie – Endgame) composto dal maestro Gyorgy Kurtag e tratto dall’omonima opera teatrale del Vate del Teatro dell’assurdo, il Premio Nobel Samuel Beckett, poi posticipata già due volte a causa dei numerosi problemi personali e di salute del compositore che hanno ritardato suo malgrado il completamento della partitura.
In realtà l’opera di Kurtag, curata dalla regia di Luc Bondy, riceverà il suo battesimo alla Scala il sei Novembre 2016 (forse), probabilmente dopo il rodaggio salisburghese, diretta da Ingo Metzmacher, analitico conoscitore della musica del ‘900 e delle sue implicazioni, lo stesso direttore, cioè, che si è reso disponibile per il podio dello spettacolo sostitutivo:”Wozzeck” di Alban Berg, appunto.
E siamo alla quarta ripresa di questo titolo, nel medesimo spettacolo di Jürgen Flimm (1997 con Sinopoli, 2000 con Conlon, 2008 con Gatti) ed il secondo della stagione affidato a questo sopravvalutatissimo regista, che vogliamo ricordarlo tra gli artefici, coadiuvato perfettamente da cantanti e direttore, del fiasco dell’ “Otello” rossiniano, in cui non aveva brillato certo per genialità, inventiva, spirito critico o senso dello stile, del gusto o dell’approfondimento: e anche con questo allestimento procede con coerente determinazione a mettere in scena il nulla delle idee.
Un paio di rigide e fisse vele rosse, una proiezione campestre un po’ kitsch, scena senza identità di Erich Wonder, cantanti privi di una caratterizzazione e abbandonati nella gestualità alla buona volontà del singolo, costumi anonimi di Florence von Gerkan, momenti confusionari farciti di sfilate ingenue, abuso di didascalismo, luci più belle in foto che dal vivo di Marco Filibeck, un’orchestrina che appare e scompare e la noia sempre più spessa che neanche il coltello del protagonista avrebbe potuto scalfire: unico guizzo, l’identificazione totale e commovente del figlio di Wozzeck e Marie con il Narr, il quale, nel finale, lo condurrà via, lontano da tutta quella follia e morte, sulle spalle, mentre il bimbo, che nulla ha compreso, continuerà il suo tragico “hopp-hopp”.
Se la regia è di disarmante povertà concettuale, anche il cast non cerca di risollevare la qualità della proposta e fa rabbia pensare che nelle tre riprese precedenti si poteva fare affidamento sulle spalle di artisti, discutibili quanto si vuole, ma rodati e reputati come Franz Grundheber, Kim Begley, Kurt Rydl, Catherine Malfitano, Graham Clark, Gunther von Kannen, Waltraud Meier, Evelyn Herlitzius: per questa ripresa si è invece puntato sull’economia vocale ed artistica, su quel minimo indispensabile, ormai marchio scaligero perseguito con indifferenza e cinismo.
 Desta perplessità una voce come quella di Ricarda Merbeth, Marie, soprano che nelle proprie frequentazioni teatrali vanta numerosi ruoli wagneriani e straussiani, che evidentemente hanno lasciato stremata la già non eccelsa vocalità di partenza (ricordo ancora la sua miagolante Elisabeth bayreuthiana affrontata nei primi anni del 2000). Se l’emissione aiuta in qualche modo questa vocina dal timbro querulo e candeggiato ad emergere dall’orchestra, il sostegno in pratica non esiste, poiché a parte un paio di note in alto, udibili, ma stridule, il centro ed il grave si presentano stimbrati, senza armonici e irrimediabilmente indietro; e se la sola scena della lettura della Bibbia risulta quanto meno decente, la fraseggiatrice vede la Merbeth davvero a mal partito a causa di un canto che nulla esprime, perché faticoso oltre che deficitario.
Desta perplessità una voce come quella di Ricarda Merbeth, Marie, soprano che nelle proprie frequentazioni teatrali vanta numerosi ruoli wagneriani e straussiani, che evidentemente hanno lasciato stremata la già non eccelsa vocalità di partenza (ricordo ancora la sua miagolante Elisabeth bayreuthiana affrontata nei primi anni del 2000). Se l’emissione aiuta in qualche modo questa vocina dal timbro querulo e candeggiato ad emergere dall’orchestra, il sostegno in pratica non esiste, poiché a parte un paio di note in alto, udibili, ma stridule, il centro ed il grave si presentano stimbrati, senza armonici e irrimediabilmente indietro; e se la sola scena della lettura della Bibbia risulta quanto meno decente, la fraseggiatrice vede la Merbeth davvero a mal partito a causa di un canto che nulla esprime, perché faticoso oltre che deficitario.
Roberto Saccà, Tamburmaggiore, associa ad uno stile grossolano, una vocalità piccola, priva di personalità nel fraseggio, sospesa tra naso e gola ed un timbro particolarmente infelice.
Delusione cocente il Capitano affidato a Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, pregevole Mime, fino a poco tempo fa e affidabile voce da caratterista, si presenta alla Scala con una intonazione erratica, una proiezione di scarsa risonanza, un timbro sbiancato ben poco incisivo e personalità scenica del tutto inefficace. Indegno compagno, il Dottore atrocissimo di Alain Coulombe, cantante inclassificabile a causa della gutturalità del timbro e di una voce indietro e ancorata allo stomaco, cortissima in alto ed in basso, priva quindi di espressività o senso della musicalità.
Gradevoli e scenicamente partecipi, l’Andres di Michael Laurenz, la Margret scura e sonora della veterana Marie-Ange Todorovitch, il Narr di Rudolf Johann Schasching.
 Tra tutti si distingue facilmente, e non perché nel paese dei ciechi l’orbo è il re, ma per meriti artistici, il baritono Michael Volle, Wozzeck, l’unica eccezione felice che emerge dalle grigie nebbie di questo cast senza nerbo.
Tra tutti si distingue facilmente, e non perché nel paese dei ciechi l’orbo è il re, ma per meriti artistici, il baritono Michael Volle, Wozzeck, l’unica eccezione felice che emerge dalle grigie nebbie di questo cast senza nerbo.
Voce instancabile, emessa senza fatica apparente e senza sbandamenti, padrone della tessitura, di una intonazione curata, di una dizione ottima e ottimamente espressa grazie ad una sempre diversa gamma di espressioni, per mezzo delle quali Volle può affidarsi ad un fraseggio di rara complessità analitica, sia del testo, soprattutto quando Berg chiede al suo personaggio di “parlare” che delle situazioni. E’ l’unico, Volle, a creare davvero una progressione psicologica, un Wozzeck maturo, commovente nella sua frustrazione incatenata, che esplode con progressione percettibile: gli scatti di follia sono realmente vibranti; la visionarietà delle scene “esterne” possiedono una dinamica di intensa comunicabilità; il tutto associato ad un timbro piacevole e schiettamente virile.
 Mi aspettavo di ricevere un pugno nello stomaco da Metzmacher, o quanto meno di partecipare emotivamente alla dissoluzione psicologica dei personaggi, di essere colpita dalle spigolosità coloratissime di Berg.
Mi aspettavo di ricevere un pugno nello stomaco da Metzmacher, o quanto meno di partecipare emotivamente alla dissoluzione psicologica dei personaggi, di essere colpita dalle spigolosità coloratissime di Berg.
Metzmacher è precisissimo, è una lettura sorella di quella regalataci da Boulez, con il quale condivide, purtroppo, i difetti oltre che i pregi: monotono, gelido e privo di contrasti e dinamiche, Metzmacher trova un unico momento di autentica pateticità nella sola lettura della Bibbia, nel quale la monotonia si stempera e si apre ad un gioco di chiaroscuri e piani sonori sottili, finalmente espressivi. Avrei preferito una differenziazione delle scene e delle situazioni sceniche, permessa e incoraggiata dalla geniale scelta di Berg di conferire un aspetto diverso ad ogni momento scenico grazie alle variazioni sui temi, sulle note o sui generi musicali, cosa ignorata dalla bacchetta di Metzmacher a discapito del fraseggio orchestrale, curatissimo, dettagliatissimo, ma depurato da ogni contrasto, da ogni identità: sempre piatto e sul mezzoforte, ogni scena diventa identica alla precedente ed alla successiva
Eppure se a Wozzeck si toglie questa particolare identità sonora, se si prosciuga la psicosi musicale, se si decide di non affidarti, non dico all’espressionismo, ma proprio all’espressione dell’orchestra, devi necessariamente riempirlo con altro. L’agogica era omogenea, pulita, ma asettica: il tono perennemente serioso, perennemente virato su un grigiore depauperato dell’allucinato vaneggiamento della partitura: e anche se il suono era indubbiamente curato, la privazione della spontaneità (anche costruita), dell’empatia, era solo un gioco sterile e irrisolto. Tutto è uguale, senza drammaticità. Tutto avviene perché deve avvenire e la musica deve andare avanti. Anche i personaggi (escluso Wozzeck) rischiano, complice una regia scialba, di risultare tutti uguali nei gesti e nell’accompagnamento, peccato capitale per me.
Mitropoulos, Bohm e Abbado e aggiungerei anche le magnifiche letture di von Dohnànyi e Barenboim, in un clima tutto in crescendo, in cui la disperazione si trasforma in personaggio, fanno in modo che il senso incombente di minaccia (chi in maniera più spinosa, chi in maniera più sfumata) si accumuli fino a deflagrare, devastante, scoprendo lentamente nevrosi e turbe psichiche, non solo liricizzando o colorando, ma anche inasprendo, accentuando la violenza dei contrasti ritmici, per creare lo straniamento psicologico e musicale e colpire, finalmente, chi ascolta.
Metzmacher e Flimm, al contrario, dicono fin dall’inizio: “Sono tutti ugualmente folli, da subito. Sono tutti uguali, e l’omicidio avviene, perché è scemo e cornuto”. Ovvero l’ennesimo caso di cronaca o una “Cavalleria rusticana” in laboratorio, senza implicazioni personali, visto dall’esterno senza occhio critico, senza senso della narrazione. Non mi ha convinto questa estraneità, questa mancanza di empatia che lascia perplessi, freddi, estranei.
Teatro mezzo vuoto, molti “forni” e platea libera, pubblico tiepido alla fine, ma molto caloroso per Volle.
(La creazione della locandina sopra, creata con Photoshop, è stata resa possibile per gentile concessione dell’amico “Sonovecchiomarobusto” )
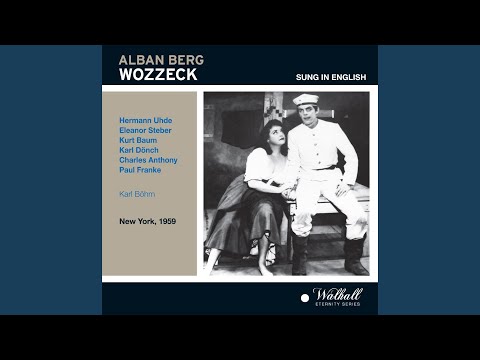
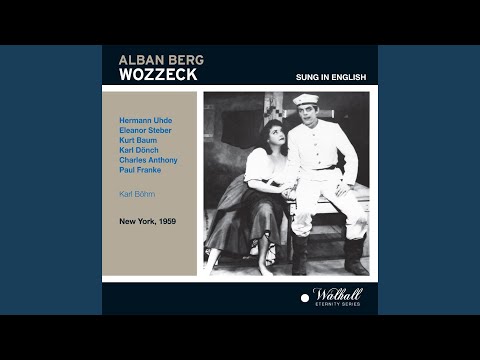
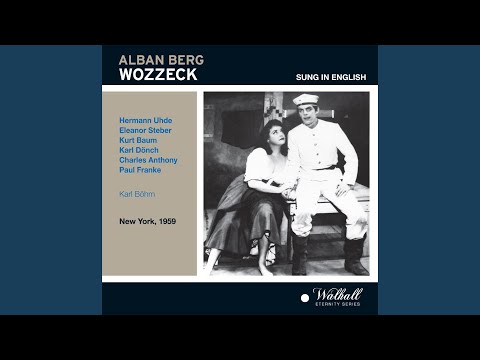




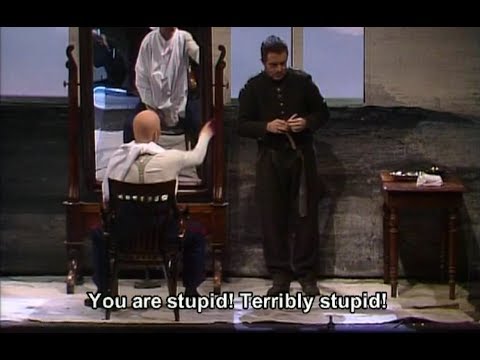




A me è sembrata un’eccellente ripresa. La direzione – assecondata egregiamente da un’orchestra in gran forma – mi è sembrata la cosa migliore, davvero notevole. La recensione di Marianne Brandt riconosce – tra le cose a suo avviso negative – il dettaglio del fraseggio, il suono curato. In effetti molto curato e di gran suggestione. Un’interpretazione limpida, chiara, luminosa, tutt’altro che priva di sfumature e monocorde, in grado di restituire – da un’angolazione senz’altro originale – un’idea efficace e antiretorica della drammaturgia di Wozzeck. E di dare conto delle formidabili suggestioni orchestrali dell’opera. Michael Volle è stato un grande Wozzeck, il resto del cast – a eccezione di un Tamburmaggiore piuttosto gracile e davvero poco protervo – ha dato complessivamente buona prova. La regia è piaciuta e il pubblico, perlomeno a tutte le recite cui ho assistito, ha applaudito calorosamente. Un successo ( con qualche vuoto in platea e troppi nei palchi ).