La regia di Vera Nemirova
E’ la legge dell’odierno storicismo generalizzato ed esagerato di volere ravvivare ed avallare tutto. Ma se da un lato si dichiara di promuovere una conoscenza critica ed un immagine completo del passato, in realtà, per mancanza di strumenti veramente critici, si finisce per livellare tutto in un discorso generico di “attualità” ed “attualizzazione” che resta il punto di partenza ciecamente affermativo per adeguarvisi i più disparati contenuti del passato.
 E allora, per lanciare il suo ciclo scenico di Meyerbeer, la Deutsche Oper invita una regista di terz’ordine che guarda alVasco de Gama, arrivata a casa accende la tv, vede notizie sulla crisi dei profughi ed è colpita dall’illuminazione: “Ma quanto è attuale l’opera di Scribe e Meyerbeer! Scrivono quasi come se fosse una storia di profughi e di fondamentalismo religiosa dei nostri giorni!”, invece di capire che la modernità del Vasco consiste piuttosto in quell’altro ieri dell’orientalismo sognante ed ottimista, realizzato con tanto lusso e tanta poesia nel lavoro di Scribe e Meyerbeer, che è all’inizio di quel dramma coloniale-imperialista di cui il profugo odierno cosi come l’odierno turista europeo sono le più radicali, tardivi manifestazioni, conseguentemente e tragicamente spezzate l’una dall’altra. Quindi, invece di tentare una vera critica al posto di mostrare e manipolare quello che vediamo comunque quotidianamente senza che questo vedere dell’”attuale” significhi necessariamente la sua comprensione critica, il 4 ottobre il pubblico si è trovato davanti ad una “lettura” da autentico Regietheater dei poveri.
E allora, per lanciare il suo ciclo scenico di Meyerbeer, la Deutsche Oper invita una regista di terz’ordine che guarda alVasco de Gama, arrivata a casa accende la tv, vede notizie sulla crisi dei profughi ed è colpita dall’illuminazione: “Ma quanto è attuale l’opera di Scribe e Meyerbeer! Scrivono quasi come se fosse una storia di profughi e di fondamentalismo religiosa dei nostri giorni!”, invece di capire che la modernità del Vasco consiste piuttosto in quell’altro ieri dell’orientalismo sognante ed ottimista, realizzato con tanto lusso e tanta poesia nel lavoro di Scribe e Meyerbeer, che è all’inizio di quel dramma coloniale-imperialista di cui il profugo odierno cosi come l’odierno turista europeo sono le più radicali, tardivi manifestazioni, conseguentemente e tragicamente spezzate l’una dall’altra. Quindi, invece di tentare una vera critica al posto di mostrare e manipolare quello che vediamo comunque quotidianamente senza che questo vedere dell’”attuale” significhi necessariamente la sua comprensione critica, il 4 ottobre il pubblico si è trovato davanti ad una “lettura” da autentico Regietheater dei poveri.
Nella Scena del Consiglio del primo atto vediamo ovviamente dei politici vestiti come i politici che appaiono ogni giorno sui telegiornali, mentre Sélika e Nélusko vengono condotti insieme ad una fola di gente che assomigliano ai profughi che appaiono ogni giorno sui telegiornali o sulle strade delle città europee. E pensare che il primo atto è ancora quello che fa un po’ senso, perché è ancora fresca la percezione di quel gigantesco mezzo-piatto grigio che rappresenta la carta geografica della Terra e che poi comincia ad alzarsi e scendere per cinque atti a seconda che servi di tavola di consiglio, muro del carcere, tolda della nave, soglia indiana o quel non so ché su cui è collato un materasso nuziale coperto di fiori arancioni che finisce per “simbolizzare” la mancinella, mentre vi passa un videoclip allusivamente erotico, intanto che sotto c’è una cantante arrivata alla fine delle forze a cui le sue ultime frasi rimangono per traverso nella gola.
 Ma questo grigio globo-sfondo-pavimento multiuso a cui si aggiungono una specie di vele che servono di cupola nel primo atto e – appunto – di vela nel terzo, sono solo il container brutto, anonimo e monotono di quel nulla che succede durante i cinque atti, ignorando beatamente tutte le didascalie cosi eloquenti del libretto, con cui, in specie nel terzo atto, alterna assurdamente un’”azione” indegna anche del teatraccio più provinciale. Dopo aver sorbito la conversione forzata di Sélika al cristianesimo durante la preghiera dei marinai – messa li senza senso, anche perché era palese l’incapacità della regista di maneggiare le ampie scene di colore che aprono l’atto della nave ‘, la ballata di Adamastor cantata da Nélusko provvede nella visione di Vera Nemirova lo spogliamento di una suora svelatasi come puttana per venire trattata come oggetto di violenza sadico-machista. Il tutto si conclude con la fucilazione dei portoghesi da parte degli indiani che qui hanno la fortuna di essere “attualizzati” come pirati somali o i guerrieri dell’Isis… o del Taliban. Ma alla fine non è uguale? E’ tutto cosi attuale! Dopo l’indicibile ethno-kitsch del quarto atto con tante di quelle danze “selvaggie” da vergognarsi al posto del team registico, arriviamo al finale in cui, come nel resto dell’opera, la regista si dimostra un’altra volta incapace di cogliere la fondamentale discrepanza, intrinseca al contenuto ed ai codici espressivi del lavoro, fra una realtà intransigente ed una dimensione di sogni ed allucinazioni artificiosamente indotti. Mentre Sélika immerge nella folla del suo popolo che tiene nelle mani quelle barchette di carta che sin dall’inizio rimanevano disperse sull’avanscena, ne emerge ancora una volta Vasco con il suo zaino da backpacker.
Ma questo grigio globo-sfondo-pavimento multiuso a cui si aggiungono una specie di vele che servono di cupola nel primo atto e – appunto – di vela nel terzo, sono solo il container brutto, anonimo e monotono di quel nulla che succede durante i cinque atti, ignorando beatamente tutte le didascalie cosi eloquenti del libretto, con cui, in specie nel terzo atto, alterna assurdamente un’”azione” indegna anche del teatraccio più provinciale. Dopo aver sorbito la conversione forzata di Sélika al cristianesimo durante la preghiera dei marinai – messa li senza senso, anche perché era palese l’incapacità della regista di maneggiare le ampie scene di colore che aprono l’atto della nave ‘, la ballata di Adamastor cantata da Nélusko provvede nella visione di Vera Nemirova lo spogliamento di una suora svelatasi come puttana per venire trattata come oggetto di violenza sadico-machista. Il tutto si conclude con la fucilazione dei portoghesi da parte degli indiani che qui hanno la fortuna di essere “attualizzati” come pirati somali o i guerrieri dell’Isis… o del Taliban. Ma alla fine non è uguale? E’ tutto cosi attuale! Dopo l’indicibile ethno-kitsch del quarto atto con tante di quelle danze “selvaggie” da vergognarsi al posto del team registico, arriviamo al finale in cui, come nel resto dell’opera, la regista si dimostra un’altra volta incapace di cogliere la fondamentale discrepanza, intrinseca al contenuto ed ai codici espressivi del lavoro, fra una realtà intransigente ed una dimensione di sogni ed allucinazioni artificiosamente indotti. Mentre Sélika immerge nella folla del suo popolo che tiene nelle mani quelle barchette di carta che sin dall’inizio rimanevano disperse sull’avanscena, ne emerge ancora una volta Vasco con il suo zaino da backpacker.
Anche se rimane incomprensibile che cosa abbia voluto dirci la regista, è certo che la signora, presentata sui giornali come una regista delle “grandi dimensioni”, non ha capito che non si può ridurre ad una scenografia sola, poi bruttissima anche quella, un’opera di cinque atti che si chiama grand-opéra non solo perché dura quattro o cinque ore, ma anche perché il lato visuale, giocato come quello musicale sistematicamente su contrasti, contrasti ed ancora contrasti o simultanei o consecutivi, è importante come la musica ed in teoria proverrebbe un naufragio, una scena trionfale e nuziale in una terra esotica e alla fine una gigantesca mancinella che è quasi un personaggio per se per il tasso poetico e narrativo assegnatoli. E se il teatro vuole assolutamente risparmiare dei soldi addirittura su un grand-opéra, quando finalmente decide di farne una, allora si fà una versione in forma di concerto come Dinorah e non si rimane con questa cosa indescrivibile che non sta da nessuna parte. Però, visto che la Deutsche Oper non intende di fare più di sei recite delVasco, allora sorge il dubbio legittimo che si è davvero voluto fare un po’ di economia, fare il suo dovere di grandi Vasco da Gama filologici riesumando una versione originale di un’opera postuma di un compositore berlinese negletto, solo per rinchiuderla nella cantina al più presto possibile e procedere ai soliti Bohème e Barbiere. Eppure, anche se non si vuole sprecare troppi soldi per mettere in scena tante processioni lussuose e tante costruzioni architettoniche monumentali, almeno si lasci l’opera seguire la sua trama, si rispetti le didascalie che sono state scritte e musicate da gente che sapeva fare teatro! E non solo teatro, ma anche un Regietheater di una modernità (ancora vivente) che i grandi “decostruttori” di oggi se la sognano.
 Come si può poi unire i primi due atti in quanto ambientati in Portogallo per isolare il terzo in quanto ambientato sulla nave e fondere insieme ancora i due ultimi atti, perché ambientati nella reggia di Sélika? Si giustifica la scelta con l’argomento geografico, però che senso ha farlo se poi la scenografia rimane quasi uguale, per tacere della regola più basilare del grand-opéra che ogni atto è costruito come un mondo a parte con i propri colori e toni scenico-musicali, nonché linee narrative perfettamente dispiegate e concluse. A differenza di Wagner che ha realmente composto degli atti che durano quasi due ore (terzo atto dei Meistersinger, prologo e primo atto della Götterdämmerung, primo atto di Parsifal), in Meyerbeer che calcolava esattamente l’equilibrio di durata tra i cinque atti, ogni fusione non può che aggravare ancora l’impressione di desolante monotonia che cosi profondamente si incide nelle anime degli spettatori obbligati a guardare gli stessi due brutti oggetti giganteschi né concreti né astratti salire e scendere per cinque ore. Ed ovviamente ci si inclina anche ad operare dei tagli per rendere digeribili gli atti monumentali fusi insieme, il ché ci porta all’altro aspetto doloroso di questo naufragio …
Come si può poi unire i primi due atti in quanto ambientati in Portogallo per isolare il terzo in quanto ambientato sulla nave e fondere insieme ancora i due ultimi atti, perché ambientati nella reggia di Sélika? Si giustifica la scelta con l’argomento geografico, però che senso ha farlo se poi la scenografia rimane quasi uguale, per tacere della regola più basilare del grand-opéra che ogni atto è costruito come un mondo a parte con i propri colori e toni scenico-musicali, nonché linee narrative perfettamente dispiegate e concluse. A differenza di Wagner che ha realmente composto degli atti che durano quasi due ore (terzo atto dei Meistersinger, prologo e primo atto della Götterdämmerung, primo atto di Parsifal), in Meyerbeer che calcolava esattamente l’equilibrio di durata tra i cinque atti, ogni fusione non può che aggravare ancora l’impressione di desolante monotonia che cosi profondamente si incide nelle anime degli spettatori obbligati a guardare gli stessi due brutti oggetti giganteschi né concreti né astratti salire e scendere per cinque ore. Ed ovviamente ci si inclina anche ad operare dei tagli per rendere digeribili gli atti monumentali fusi insieme, il ché ci porta all’altro aspetto doloroso di questo naufragio …
La direzione ed i tagli
Per tacere dell’indecente menzogna di aver tagliato solo “qualche balletto”, quel “qualche passaggio” in più tagliato per rendere reggibili ai protagonisti le loro parti è stato altrettanto distruttivo quanto nella versione di Fétis. A parte la lunga marcia indiana che introduce il quarto atto ed i tagli a tutte le sezioni del finale di Sélika che non siano state già ascoltate nelle accorciate versioni tradizionali eccetto l’apertura del taglio alla variante lunga del Coro aereo e l’omissione del duettino con Nélusko vi introdotto da Fétis, è stato ancora una volta distrutto il terzo atto. Oltre alla sezione lenta del duetto dei duellanti Vasco e Don Pedro, ne è stato cancellato addirittura quel affascinante settetto che segue la presa in ostaggio di Inès da parte di Sélika nonché la scena duettata tra Nélusko e Sélika prima della tempesta in cui decidono di morire insieme dalla mano di Don Pedro. Cosicché il terzo atto ne è risultato molto più corto degli altri atti, da dove anche l’assurdità dell’isolamento del terzo atto da due pause, e perlopiù è stato ridotto allo stesso azionismo assurdo da colportage, priva di musica importante, che aveva lasciato profondamente insoddisfatto la critica già alla prima del 1865. Insomma, un’operazione che sarebbe uguale a tagliare le arie e lasciare solo i recitativi per fare almeno avanzare la trama.

Non sapendo se l’iniziatore dei tagli fosse soprattutto la regista, qualche cantante o il direttore d’orchestra Enrique Mazzola, che per dei meriti da me ignorati viene celebrato come grande specialista del repertorio belcantistico a cui hanno improvvisamente aggiunto il grand-opéra, i tagli e soprattutto quelli al terzo atto, aggravati poi da una regia particolarmente brutta, hanno dimostrato che per accorciare il gigantesco spartito non si è fatto troppi scrupoli e si è preferito copiare ancora una volta le soluzioni provate del buon Fétis. Ovviamente sarebbe impossibile eseguire tutto il materiale senza apportare qualche modificazione. Meyerbeer era il primo a tagliare dal suo spartito tutto quello che li pareva superfluo secondo l’effetto prodotto durante le prove sceniche. A differenza dei lavori anteriori, è la sua morte ad avere impedito il compimento di un simile sperimento durante le prove del Vasco/L’Africaine. Ma una cosa è certa: anche se avesse tagliato due ore di musica, il maestro sarebbe ancora riuscito di ottenerne un miglior risultato teatrale, invece di distruggerne il senso drammaturgico e musicale. Come direbbe il mio collega Nourrit, anche tagliare è un’arte e di quest’arte il signor Mazzola come capitano del grande viaggio musicale non si è certo mostrato essere un maestro…
Per non parlare poi di com’è stato tenuto l’orchestra sin dalle prime battute in cui l’attacco spento degli ottoni ci ha fatto capire che le cose non sarebbero andate molto bene per le prossime cinque ore della nostra esistenza. Disturbante la mancanza di coordinamento tra buca e palcoscenico e, del resto, una prestazione di pessimo livello da parte del coro soprattutto nel primo atto in cui i signori del Consiglio, coll’unisono della loro affascinante melodia da marcia, rivestono il ruolo di un vero protagonista. Orchestra spenta e svogliata a rendere i piccoli dettagli raffinatissimi dello spartito di un vecchio genio di strumentazione, cosi strano e in certi punti minimalista nel evocare grandi passioni e svolte con dei mezzi minuscoli, con qualche accordo, con qualche mistura inconsueta di strumenti. A differenza delle felici eccezioni recenti di un Minkowski o di un Beermann, Enrique Mazzola si è mostrato profondamente incapace di cogliere la specificità del dinamismo del metodo musicale di Meyerbeer brevemente accennato nella parte anteriore di questo saggio, ossia un dialettico avanzare non per un flusso “wagneriano”, ma per la demarcazione di frammenti e sezioni che vengono allineati in un ordine esattamente pensato e che rivestono ciascuno un carattere assolutamente distinto oltreché contengano ognuno ancora ulteriori elementi di contrasto che nell’ambito di una sezione viariano a seconda la necessità drammaturgica. Il ché risulta in un avanzare dinamicissimo (perché molto variato) per sezioni chiusi o quasi, senza mai operare dei “passaggi”, delle transizioni fluide che erano l’arma segreta di un Wagner. Cosi nel finale quinto, l’allucinazione di Sélika è differenziata in una successione di recitativi, ariosi ed arie ben distinti gli uni dagli altri che guarda piuttosto al modello delle scene classiche del tipo della Gran Scena di Ermione in cui ogni sezione dipinge con mezzi precisamente scelti un affetto o pensiero diverso. E’ un metodo che non vuole mai “inebriarci”, neanche quando si indulge in arie spianate all’italiana; vuole una musica teatrale, esatto e caratteristico, fino al midollo. E’ per questa costruzione via una successione di sezioni ben delimitate che alla fine sarebbe un’impresa molto più difficile tagliare in Meyerbeer (il quale, tra l’altro, scrive seguendo un metodo che detterebbe come e dove tagliare) che non in un’opera composta in forma aperta (i tagli nel secondo atto del Tristan o nell’Elektra, tra l’altro approvati dai compositori stessi, ci tolgono magari una decina di minuti in più di piacere musicale, ma, paradossalmente, non distruggono né il flusso musicale né il lavoro di caratterizzazione). Cade poi anche Mazzola nella trappola di volere negligere il resto per enfatizzare tanto più i momenti di “effetto” fino ad incitare – oppure cedere – a quel grottesco esemplare di divismo che è stato l’arrivo di Vasco nel quarto atto e l’esecuzione della sua famosa aria.
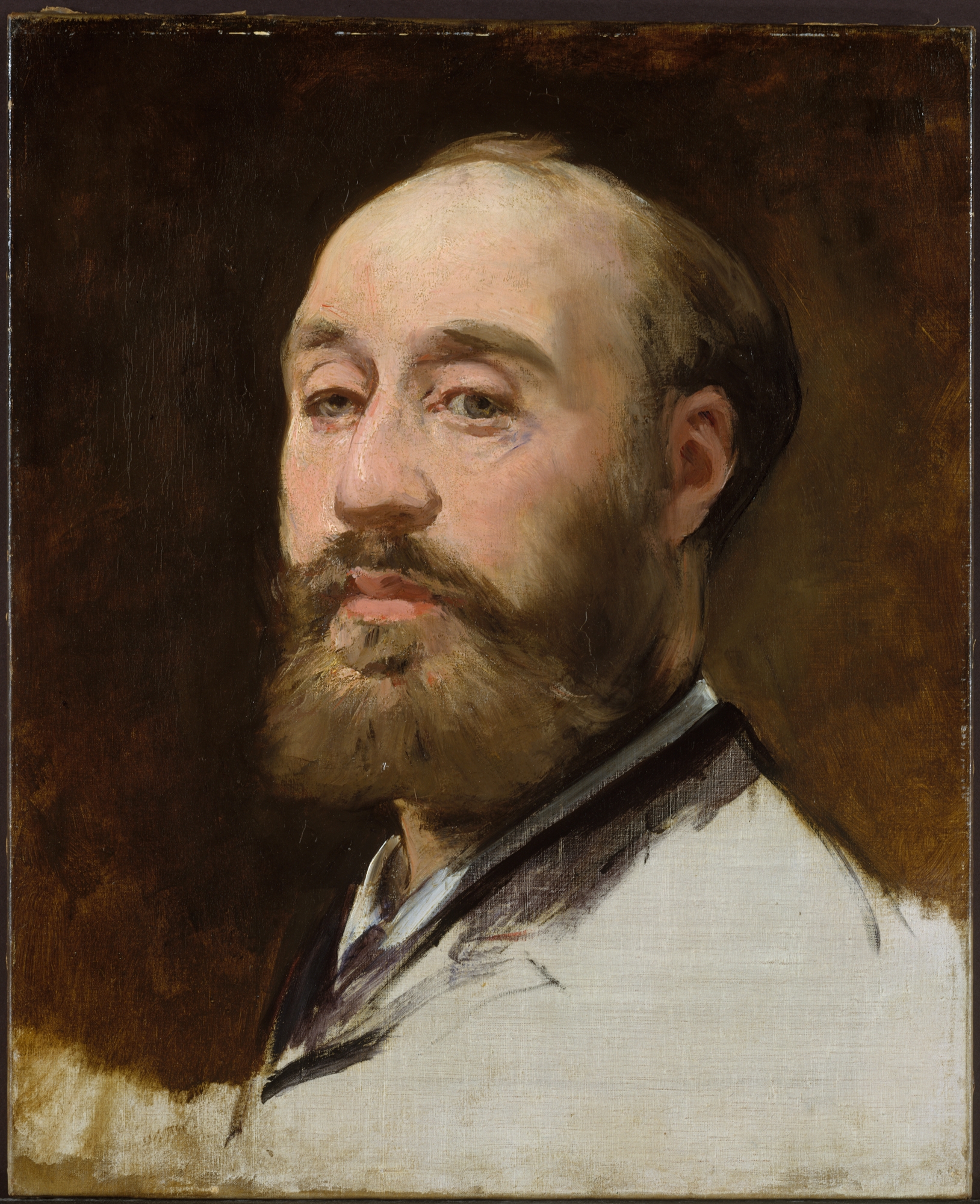 Prima di passare sulla resa dell’aria da parte di Roberto Alagna, soffermiamoci su un ultimo aspetto del metodo compositivo di Meyerbeer. Abbiamo visto che o la sua musica si fa a pezzi tagliandone delle parti senza considerare l’insieme per poi lamentarsi che sia musica frammentata ed incongrua, o la si “pensa” frammentata, senza capire il procedere dialettico descritto più sopra, il ché riguarda anche l’approccio abituale alle melodie di Meyerbeer considerate cosi spesso prive di autentica ispirazione. Certo che soprattutto nel Vasco si può a tratti osservare un’invenzione melodica un poco “stanca”, ma va anche sottolineata che la melodia meyerbeeriana non può mai diventare “assoluta” al pari delle divine melodie di un Bellini, perché sia un’aria come “Robert, toi que j’aime” o appunto l’aria di Vasco testimoniano di un perfetto accostamento e compenetrazione di cantabilità all’italiana e declamato. Nell’arte si fa non solo quello che si può, ma spesso si può e si fa proprio quel che è dettato dalla matrice estetica. I diversi gradi di contenuto verbale-drammatico abbisognano, dettano, una modificazione, anzi un addomesticamento, corrispondente nel materiale musicale-vocale – un procedimento attribuito come merito a Wagner e Verdi, visto come mancanza d’ispirazione in Meyerbeer…
Prima di passare sulla resa dell’aria da parte di Roberto Alagna, soffermiamoci su un ultimo aspetto del metodo compositivo di Meyerbeer. Abbiamo visto che o la sua musica si fa a pezzi tagliandone delle parti senza considerare l’insieme per poi lamentarsi che sia musica frammentata ed incongrua, o la si “pensa” frammentata, senza capire il procedere dialettico descritto più sopra, il ché riguarda anche l’approccio abituale alle melodie di Meyerbeer considerate cosi spesso prive di autentica ispirazione. Certo che soprattutto nel Vasco si può a tratti osservare un’invenzione melodica un poco “stanca”, ma va anche sottolineata che la melodia meyerbeeriana non può mai diventare “assoluta” al pari delle divine melodie di un Bellini, perché sia un’aria come “Robert, toi que j’aime” o appunto l’aria di Vasco testimoniano di un perfetto accostamento e compenetrazione di cantabilità all’italiana e declamato. Nell’arte si fa non solo quello che si può, ma spesso si può e si fa proprio quel che è dettato dalla matrice estetica. I diversi gradi di contenuto verbale-drammatico abbisognano, dettano, una modificazione, anzi un addomesticamento, corrispondente nel materiale musicale-vocale – un procedimento attribuito come merito a Wagner e Verdi, visto come mancanza d’ispirazione in Meyerbeer…
E siccome dopo la prima berlinese del Vasco il pubblico cerca di aggrapparsi a qualche “bella melodia” che è riuscito d’incontrare in mezzo a tanta vaghezza, mentre la critica, tragicamente ignorante in materia meyerbeeriana, continua – perché di certo poco aiutata dall’allestimento per cambiare d’avviso – a ripetere i soliti luoghi comuni sui “colpi di scena” intorno a cui tutto diventa un pretesto, andrebbe sottolineato con enfasi anche la seguente regola fondamentale: Al contrario di quanto sostenuto dal diffamatore Wagner sugli “effetti senza causa”, nel grand-opéra ogni numero, ogni personaggio, ogni danza ed azione è motivato dall’esigenza drammaturgica. Proprio per questo si sceglievano trame che rendevano plausibilmente possibile l’introduzione di balletti e di cosiddetti “colpi di scene”. E’ al posto “giusto” la seconda aria del paggio introdotto ne Les Huguenots per la diva Alboni; è codificato allo scopo di un particolare significato drammaturgico la risoluzione di un personaggio attraverso una vocalità acrobatica, mentre un altro rimane rilegato al declamato patetico. Ed è proprio per questa profonda funzionalità di ogni dettaglio che le “deviazioni” saltavano dolorosamente agli occhi. Era questo il caso con le roulades della grande aria del quinto atto di Fidès, palesamente concepito come un omaggio all’arte della Viardot ed era parzialmente il caso con la Ballata di Nélusko di cui la critica non capì il significato, siccome, in quanto ballata, non raccontava nessuna storia, invece faceva solo paura e disturbava per la discrepanza del “selvaggio” Nélusko con la bellissima voce e raffinita vocalità del più celebre baritono francese dell’Ottocento Jean-Baptiste Faure.[1]
I cantanti
E’ quasi un sacrilegio menzionare il nome del mitico creatore della parte di Nélusko la cui unica incisione all’età di 70 anni ci fa sentire una voce molto più fresca, puntata ed agile che tutte quelle insieme che abbiamo sentito il 4 ottobre nei ruoli primari o secondari del Vasco de Gama. A parte i numerosi bassi secondari, ma in realtà importantissimi per i suoi compiti comunque brevi, che “sostengono” l’ossatura dello spartito vocale e che a Berlino o si sentivano poco o dimostravano una voce invecchiata, capeggiati da un durissimo Don Pedro del giovane Seth Carico, ha ballato in alto, gonfiato al centro e scurito in basso una Nino Machaidze per darsi peso e colore per il ruolo d’Inès assolutamente inadatto sia alla natura del suo strumento sia alle sue capacità tecniche.
 Roberto Alagna, divo attesissimo, si fece annunciare colpito di una grippa di cui sentimmo prove evidentissime quali tosse e starnuti ed è considerando questo fatto che li va attribuito il merito di avere comunque cantato una parte tutt’altro che facile. Fu l’unico dei cantanti (e in generale di tutti i collaboratori di questa produzione) che pare abbia avuto un’idea di come bisogna fare Meyerbeer, sfoggiando al centro un timbro ancora piuttosto sano e sonoro ed un fraseggio molto colpito, sostenuto da un francese idiomatico, nella monumentale Scena del Consiglio. I problemi sono arrivati con le prime frasi acute e pesanti del finale primo – problemi che perseverano da lui anche quando si esibisce in perfetta salute. Cosi, durante l’intera serata abbiamo ascoltato un cantante che sapeva rendere tutto quello che era scritto sotto il passaggio tenorile – va menzionato “O ma Sélika” del duetto d’amore del quarto atto – mentre il registro acuto era sistematicamente penalizzato da un metodo forzato di canto che risultava in suoni stonati e sbiancati. Quel che avrebbe dovuto essere l’uso della voce mista o del falsettone finiva nell’emissione di suoni incolori e privi di qualsiasi sonorità. E’ stato niente meno che grottesco la sua apparizione all’aria “O doux climat/O paradis”. Abbandonato dalla regia incapace di sottolineare il minimo contrasto, questa scena in cui Vasco, trascinato dai sacrificatori, si gela in un attimo di irreale incantesimo per la bellezza del “nuovo mondo” e per il proprio glorioso futuro senza rendersi più conto che è sul punto di essere sterminato, è stato cantato dal divo con un tempo dilatato fino all’impossibile (non so per volontà sua o per una “interpretazione” particolarmente felice del direttore-specialista), quindi stonato dall’inizio alla fine, con una coda presuntuosamente stentorea, con il risultato complessivo di distruggere ancora un momento ineguagliabile del senso drammaturgico di Meyerbeer. Al termine di questo “O paradis” nessun sogno che si spezza né nella resa visiva né in quella musicale. E nemmeno un momento “assoluto” di virtuosismo canoro. Poi si darà colpa a Meyerbeer che scrive solo per colpire per via di “effetti”, quelli che con i cantanti d’oggi non si lasciano nemmeno ottenere a differenza di quanto ascoltiamo nei 78 giri.
Roberto Alagna, divo attesissimo, si fece annunciare colpito di una grippa di cui sentimmo prove evidentissime quali tosse e starnuti ed è considerando questo fatto che li va attribuito il merito di avere comunque cantato una parte tutt’altro che facile. Fu l’unico dei cantanti (e in generale di tutti i collaboratori di questa produzione) che pare abbia avuto un’idea di come bisogna fare Meyerbeer, sfoggiando al centro un timbro ancora piuttosto sano e sonoro ed un fraseggio molto colpito, sostenuto da un francese idiomatico, nella monumentale Scena del Consiglio. I problemi sono arrivati con le prime frasi acute e pesanti del finale primo – problemi che perseverano da lui anche quando si esibisce in perfetta salute. Cosi, durante l’intera serata abbiamo ascoltato un cantante che sapeva rendere tutto quello che era scritto sotto il passaggio tenorile – va menzionato “O ma Sélika” del duetto d’amore del quarto atto – mentre il registro acuto era sistematicamente penalizzato da un metodo forzato di canto che risultava in suoni stonati e sbiancati. Quel che avrebbe dovuto essere l’uso della voce mista o del falsettone finiva nell’emissione di suoni incolori e privi di qualsiasi sonorità. E’ stato niente meno che grottesco la sua apparizione all’aria “O doux climat/O paradis”. Abbandonato dalla regia incapace di sottolineare il minimo contrasto, questa scena in cui Vasco, trascinato dai sacrificatori, si gela in un attimo di irreale incantesimo per la bellezza del “nuovo mondo” e per il proprio glorioso futuro senza rendersi più conto che è sul punto di essere sterminato, è stato cantato dal divo con un tempo dilatato fino all’impossibile (non so per volontà sua o per una “interpretazione” particolarmente felice del direttore-specialista), quindi stonato dall’inizio alla fine, con una coda presuntuosamente stentorea, con il risultato complessivo di distruggere ancora un momento ineguagliabile del senso drammaturgico di Meyerbeer. Al termine di questo “O paradis” nessun sogno che si spezza né nella resa visiva né in quella musicale. E nemmeno un momento “assoluto” di virtuosismo canoro. Poi si darà colpa a Meyerbeer che scrive solo per colpire per via di “effetti”, quelli che con i cantanti d’oggi non si lasciano nemmeno ottenere a differenza di quanto ascoltiamo nei 78 giri.
Inès e Vasco, i personaggi “bianci”, quindi “normali” hanno almeno l’avvantaggio di cantare sempre spianato, nello già menzionato stile mescolato di cantabile italiano e declamato, con qualche cadenza ornata. Invece a Berlino i due personaggi “esotici” hanno dato luogo alle più profonde malintese stilistiche con cui rendere il peggior servizio a Meyerbeer. Venne unanimemente acclamato il baritono “di casa” Markus Brück che trasformò Nélusko in una specie di volgare Alberich da bassa provincia, dipingendo con un realismo ugualmente becero sia il lato “barbarico” che quello “nobile” del servo geloso, fedele, intrigante e fanatico. Brück è stato incapace di eseguire il ruolo su quel livello di astrattezza musicale che sistematicamente traduce le violenti passioni del selvaggio in trilli, agilità e frasi scandite con vigore, ma senza volgarità. Una malintesa da chi dirigeva lo spettacolo, da chi cantava il ruolo e da chi applaudì la sua prestazione, perché ugualmente alieni al linguaggio meyerbeeriano che del canto stranamente frammentato e fiorito di Nélusko fa la cifra musicale che rappresenta la sua “alterità”.
 E’ altrettanto chiave musicale di esotismo e producente di un effetto di “alienamento”, quando nel 1865 si ascolta una regina indiana che canta un air du sommeil tutto giocato sui minimi passi di agilità, mezze-voci spettrali, trilli alternati con passaggi di declamato incisivo. Invece, sia nel caso di Markus Brück che in quello della Sélika di Sophie Koch abbiamo da fare con cantanti incapaci ad eseguire qualsiasi agilità, produrre un suono libero, galleggiante sia sul piano che sul forte, e quindi di distinguere stilisticamente fra stilemi belcantistici e quelli di tipo francese e dare musicalmente ai personaggi il carattere preciso che in Meyerbeer non si lascia mai sostituire da nessuna “credibilità” scenica. E’ cosi che è caduta in una monotonia totale un personaggio ricco di colori come Sélika. Si chiede chi ha avuto l’idea di proporre il ruolo di Sélika che richiede uno strumento sonoro ed agile dai gravi fino agli estremi acuti ad un nominale mezzo-soprano che in acuto emette suoni pesanti e stonati, è incapace di cantare mezza-voce, ha un centro gonfiato, incolore e fiacco, nonché un registro grave in cui l’incapacità di passare correttamente al petto si paga – perdonate l’espressione – con dei veri e propri rutti deglutiti, per non parlare della pessima dizione (molto logica, visto il bagaglio tecnico della cantante, ma comunque raccapricciante, trattandosi pur sempre di una francese) e della totale assenza di qualsiasi accento o almeno “abbandono” da singing actress.
E’ altrettanto chiave musicale di esotismo e producente di un effetto di “alienamento”, quando nel 1865 si ascolta una regina indiana che canta un air du sommeil tutto giocato sui minimi passi di agilità, mezze-voci spettrali, trilli alternati con passaggi di declamato incisivo. Invece, sia nel caso di Markus Brück che in quello della Sélika di Sophie Koch abbiamo da fare con cantanti incapaci ad eseguire qualsiasi agilità, produrre un suono libero, galleggiante sia sul piano che sul forte, e quindi di distinguere stilisticamente fra stilemi belcantistici e quelli di tipo francese e dare musicalmente ai personaggi il carattere preciso che in Meyerbeer non si lascia mai sostituire da nessuna “credibilità” scenica. E’ cosi che è caduta in una monotonia totale un personaggio ricco di colori come Sélika. Si chiede chi ha avuto l’idea di proporre il ruolo di Sélika che richiede uno strumento sonoro ed agile dai gravi fino agli estremi acuti ad un nominale mezzo-soprano che in acuto emette suoni pesanti e stonati, è incapace di cantare mezza-voce, ha un centro gonfiato, incolore e fiacco, nonché un registro grave in cui l’incapacità di passare correttamente al petto si paga – perdonate l’espressione – con dei veri e propri rutti deglutiti, per non parlare della pessima dizione (molto logica, visto il bagaglio tecnico della cantante, ma comunque raccapricciante, trattandosi pur sempre di una francese) e della totale assenza di qualsiasi accento o almeno “abbandono” da singing actress.
Assolutamente privi di musicalità e di senso per lo stile meyerbeeriano anche i tanti pezzi d’assieme (o solistici) interamente o parzialmente a cappella che sono particolarmente numerosi nel Vasco, come se le voci fossero divenute anche loro dei strumenti d’orchestra piazzati sul palcoscenico. Ogni volta quando le voci erano costretti ad esporsi, a denudarsi completamente come nelle tante cadenze, nell’appello di Nélusko ai marinai, nella romanza d’Inès etc., ogni piacere d’ascolto veniva penalizzata dalla paura (tropo spesso realizzata) che si aveva per la mancanza di una perfetta intonazione indispensabile qui come mai.
Insomma, se oggi Meyerbeer non si lascia più ravvivare come un grande compositore di voci – cioè, siccome non ci sono e non ci saranno né dei Tamagno, né delle Sigrid Onegin né, al limite, una Marilyn Horne (a cui mancava una sola cosa per essere una meyerbeeriana perfetta: un sontuoso strumento vocale), perché è l’intero sistema che non permette uno sviluppo normale, nonché straordinario, delle capacità vocali ed artistiche – che cosa rimane da fare? Come nel caso di Chemnitz, si potrebbe almeno tentare di presentare l’ampiezza e la perfetta costruzione delle concezioni teatrali di Meyerbeer e ridarle la loro modernità musico-drammaturgico troppo presto negletta e falsificata. Se poi mancano pure i direttori per guidare cantanti di limitate capacità nel affrontare dignitosamente il compito, e registi capaci di cogliere il significato dei codici teatrali del grand-opéra, allora sarebbe forse meglio lasciare ai morti la pace. Perché in questo caso costa davvero tanti soldi e tanto tempo.
 Se oggi, a dispetto della mancanza di voci, Wagner si lascia fare, perché – sicuramente malgrado Wagner stesso – c’è tutto un sistema lirico “strawagnerizzato” che permette che le urla ed i suoni brutti siano persino la precondizione per l’apprezzamento del teatro wagneriano; se oggi si continua ad eseguire Verdi e Puccini, perché, inesauribilmente melodici che sono, piacciono anche senza grandi prestazioni e perché sono per noi la quintessenza stessa di cos’è l’opera; se, dopo la Rossini-Renaissance, si continua con una molto infelice Rossini-Maintenance, perché Rossini ha fatto in tempo a ritrovare la via d’accesso ai cuori degli ascoltatori moderni, che cosa significa il carattere sempre mezzo-tiepido, mezzo-abortito, dei tentativi odierni di risuscitare Meyerbeer? Questo genio universale e cosmopolita rimane affetto da una certa impenetrabilità, perché rappresenta proprio quella modernità del teatro lirico della metà dell’Ottocento che, a parte la mobilizzazione di vasti mezzi teatrali, non solo mette la grande tradizione vocale al servizio di una drammaticità divenuta modello per i Verdi e Wagner che sono finiti per usurpare l’intero merito della “modernizzazione” dell’opera, ma lascia sempre esposto il lato tecnico, artigianale di questa drammaticità, non ha mai intenzione di fare assorbire il sapere-fare nell’effetto drammatico. E’ questo che rende Meyerbeer una figura anfibica che in un’opera come Le Prophète sembra prattichi un teatro musicale che Verdi e Wagner saranno disperatamente costretti ad emulare, ma è immenso l’abisso che li separa anche per il semplice costume di Meyerbeer di scrivere le sue parti a seconda le capacità dei cantanti individuali, mentre negli stessi anni Verdi e Wagner sono appunto le figure centrali a rompere con questa tradizione. Creando e parlando un linguaggio mi melodia, di pathos, di drammaturgia e tematiche che noi dovremmo riconoscere ancora come “nostri”, perché il ruolo di Meyerbeer va molto oltre il semplice essere stato un “modello” per Wagner, Verdi o persino Puccini, Meyerbeer ci sembra quasi più lontano che un Rossini o gli altri belcantisti e romantici. Sarà proprio per il suo carattere anfibico? Facendo un teatro lirico di una modernità che dominerà i teatri fino alla Prima Guerra Mondiale, Meyerbeeer mantiene sempre quella ostentazione tutta classica, rossiniana, kantiana, della “tecnica”, del “materiale da costruzione” che si chiama “arte” nel senso in cui arte significa produrre con il suo sapere-fare artigianale un effetto artistico tanto immenso quanto consapevole della sua provenienza “tecnica”. E’ quella simulazione “sincera” che in Meyerbeer logicamente si ritrova non solo sul piano della sua prassi vocale e compositiva, ma anche nella sua visione artistica quasi cinica del mondo politico-sociale che non avrebbe mai potuto produrre personaggi affermativi come Rienzi o Lohengrin. Meyerbeer è la coscienza sporca della lirica d’oggi, perché proprio lui rende clamorosamente, sintomaticamente manifesto che cos’è che manca oggi alla lirica: il sapere ed il fare.
Se oggi, a dispetto della mancanza di voci, Wagner si lascia fare, perché – sicuramente malgrado Wagner stesso – c’è tutto un sistema lirico “strawagnerizzato” che permette che le urla ed i suoni brutti siano persino la precondizione per l’apprezzamento del teatro wagneriano; se oggi si continua ad eseguire Verdi e Puccini, perché, inesauribilmente melodici che sono, piacciono anche senza grandi prestazioni e perché sono per noi la quintessenza stessa di cos’è l’opera; se, dopo la Rossini-Renaissance, si continua con una molto infelice Rossini-Maintenance, perché Rossini ha fatto in tempo a ritrovare la via d’accesso ai cuori degli ascoltatori moderni, che cosa significa il carattere sempre mezzo-tiepido, mezzo-abortito, dei tentativi odierni di risuscitare Meyerbeer? Questo genio universale e cosmopolita rimane affetto da una certa impenetrabilità, perché rappresenta proprio quella modernità del teatro lirico della metà dell’Ottocento che, a parte la mobilizzazione di vasti mezzi teatrali, non solo mette la grande tradizione vocale al servizio di una drammaticità divenuta modello per i Verdi e Wagner che sono finiti per usurpare l’intero merito della “modernizzazione” dell’opera, ma lascia sempre esposto il lato tecnico, artigianale di questa drammaticità, non ha mai intenzione di fare assorbire il sapere-fare nell’effetto drammatico. E’ questo che rende Meyerbeer una figura anfibica che in un’opera come Le Prophète sembra prattichi un teatro musicale che Verdi e Wagner saranno disperatamente costretti ad emulare, ma è immenso l’abisso che li separa anche per il semplice costume di Meyerbeer di scrivere le sue parti a seconda le capacità dei cantanti individuali, mentre negli stessi anni Verdi e Wagner sono appunto le figure centrali a rompere con questa tradizione. Creando e parlando un linguaggio mi melodia, di pathos, di drammaturgia e tematiche che noi dovremmo riconoscere ancora come “nostri”, perché il ruolo di Meyerbeer va molto oltre il semplice essere stato un “modello” per Wagner, Verdi o persino Puccini, Meyerbeer ci sembra quasi più lontano che un Rossini o gli altri belcantisti e romantici. Sarà proprio per il suo carattere anfibico? Facendo un teatro lirico di una modernità che dominerà i teatri fino alla Prima Guerra Mondiale, Meyerbeeer mantiene sempre quella ostentazione tutta classica, rossiniana, kantiana, della “tecnica”, del “materiale da costruzione” che si chiama “arte” nel senso in cui arte significa produrre con il suo sapere-fare artigianale un effetto artistico tanto immenso quanto consapevole della sua provenienza “tecnica”. E’ quella simulazione “sincera” che in Meyerbeer logicamente si ritrova non solo sul piano della sua prassi vocale e compositiva, ma anche nella sua visione artistica quasi cinica del mondo politico-sociale che non avrebbe mai potuto produrre personaggi affermativi come Rienzi o Lohengrin. Meyerbeer è la coscienza sporca della lirica d’oggi, perché proprio lui rende clamorosamente, sintomaticamente manifesto che cos’è che manca oggi alla lirica: il sapere ed il fare.
[1] Si veda un altro interessante saggio di Gabriela Cruz, sul terzo atto dell’Africaine, “Laughing at History: The Third Act of Meyerbeer’s “L’Africaine””, Cambridge Opera Journal, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1999).




Grandiosa la nostra Giuditta omaggi domenico donzelli
Grazie, collega!
Bravaaaaa! Ho aspettato il finale per applaudire questo articolo sontuoso, che a mio parere a Meyerbeer rende un omaggio ben piu bello dello spettacolo recensito. Ogni parte (che sembrava lunghissima sullo schermo all’inizio) è stata cosi interessante che all’ultimo paragrafo c’era sempre la sorpresa “Già finita?!”
A me Meyerbeer piace molto, in modo intuitivo direi, perché mi resta tanto camino da fare con gli ascolti. Che fortuna di continuare questo camino nella prospettiva ricca fornita dall’articolo! Il bellissimo paragrafo conclusivo sul sapere-fare artigianale mi da (forse) anche la chiave per spiegare la mia preferenza intuitiva.
Dall’altra parte commincio a domandarmi se combinare una visita a Stuttgart con Le Prophète andato in scena ieri a Karlsruhe sia cosa curiosa o … dannosa …
Credo che le foto dello spettacolo di Karlsruhe siano di per sé eloquenti
http://www.staatstheater.karlsruhe.de/programm/fotogalerie/2138/
puro Regieteather all’ennesima potenza, per dirlo alla latina solo coenum ac stercus.
Si, anch’io avevo pensato di andare a Karlsruhe, ma poi ho visto le foto. Poi, dicono che hanno tagliato tutte le riprese… Non si dice nulla sul finale ultimo. Sarei molto curiosa di sentirla senza i tagli che lo rendono davvero troppo corto, anche se l’accelleramento musicale e narrativo potrebbe anche starci.
Erudita, equilibrata, geniale: splendida Judy!
Però un lieve editing che sistemasse la lingua gioverebbe, a lei in primis.
Grazie, CdG.
Grazie, mia cara, e chiedo, anzi SOGNO, anch’io un editing (non solo lieve), ma da sola è questo il mio massimo. altrimenti, je suis faible, car je suis femme…
Quando Vi aggrada.
Serva Vostra…..
Di nuovo complimenti per lo splendido articolo e l’approfondita analisi dell’esecuzione, nonchè per i giudizi estremamente precisi e motivati.
E se Alagna, nonostante tutto, “fu l’unico dei cantanti (e in generale di tutti i collaboratori di questa produzione) che pare abbia avuto un’idea di come bisogna fare Meyerbeer, sfoggiando al centro un timbro ancora piuttosto sano e sonoro ed un fraseggio molto colpito, sostenuto da un francese idiomatico, nella monumentale Scena del Consiglio”, siamo messi proprio bene!
Povero Meyerbeer!
Non so come abbia fatto Alagna nelle recite ulteriori (dovevo andare anche alla seconda, ma, pur avendo un biglietto, ho deciso che era meglio stare a casa), ma sicuramente i problemi fondamentali avranno perseverato…
Non voglio neanche sapere chi chiameranno per gli Ugonotti dell’anno prossimo. Almeno ci sarà la regia di Herheim che ha sempre qualcosa da dire e che ama comunque l’opera, ma se, oltre a cantanti poco preparati, richiamano uno come Mazzola, non so… Poi mi sembra che la critica tedesca sta riscoprendo Meyerbeer in modo molto ristretto… ossia, come pane per i denti del Regietheater, con tutti i temi di fondamentalismo, fanatismo, “radicalizazzione”, colonialismo etc. etc.
Se Herheim tratterà Gli Ugonotti come ha trattato la povera Rusalka nello spettacolo recentemente andato in scena a Lione (ambientazione in quartiere a luci rossi, in scena battone e magnaccia etc.), poveri Ugonotti! altro che la notte di S. Bartolomeo!