 Si racconta che quando, nel luglio del 1860, Wagner incontrò Rossini nella sua villa di Passy, appena fuori Parigi, tra i vari discorsi in merito ai destini del teatro d’opera, osservò come, con il suo Guillaume Tell, avesse raggiunto un perfetto connubio tra parola e musica (in particolare si riferiva al “Sois immobile!”): a quel punto Rossini, divertito, chiese con sarcasmo “E così ho fatto musica dell’avvenire?”, “No Maestro! Avete fatto musica per tutti i tempi”. Purtroppo Wagner fu cattivo profeta: l’estremo capolavoro rossiniano, infatti, rimase musica per “nessun tempo”! Più ammirato e celebrato (addirittura innalzato a onori divini da un entusiasta Donizetti), che realmente compreso, il Guillaume Tell restò un modello mai compiutamente seguito, un unicum, un’opera “inattuale” (come avrebbe detto Nietzsche). Alle difficoltà formali si unirono ben presto i mutamenti di gusto (l’incombenza del romanticismo e l’avvento del dramma musicale) e le problematiche esecutive: in breve tempo l’opera – dopo una serie di rimaneggiamenti e riduzioni – sparì dalle scene e la sua compiuta riscoperta venne sempre rinviata a “momenti migliori”. Anche nel nostro secolo il titolo rimase poco frequentato o proposto in edizioni del tutto discutibili quanto a integrità testuale e stilistica, e affidato ad interpreti largamente inadeguati (fanno eccezione le poche renaissance degli ultimi anni): nei teatri come nelle sale d’incisione. Per tutto questo una nuova edizione del Guillaume Tell è un vero e proprio evento. Tanto più che – nel presente caso – viene eseguita (in edizione critica) la versione originale francese e non la cattiva traduzione ritmica del Bassi (che tanto danneggia la linea musicale rossiniana, con modifiche arbitrarie e sgradevoli alterazioni per “adattare” la lingua italiana ad una musica scritta appositamente sulla prosodia francese). Grande merito va dunque tributato ad Antonio Pappano che, a capo delle magnifiche compagini di Santa Cecilia, ha fortissimamente voluto l’operazione. Operazione che, purtroppo, passato l’iniziale entusiamo e dopo un ascolto approfondito, appare come un’occasione non pienamente colta, atteso l’esito deludente da parte di taluni interpreti e qualche dubbio sulle scelte testuali. L’incisione EMI (di qualità non eccellente peraltro: squilibrio voce/orchestra, qualche distorsione nelle frequenze più alte e, soprattutto, fastidiosa presenza di colpi di tosse et similia, a testimonianza della maleducazione del pubblico italiano, sempre più adatto ai “sanatori” che alle sale da concerto) è il frutto di un collage di concerti, registrati a Roma tra l’autunno e l’inverno del 2010: l’opera, eseguita in forma di concerto nell’autunno del 2010, era, infatti, privata dei divertissement di I e III atto, che sono stati incisi separatamente nel corso di alcuni concerti natalizi nel medesimo anno. Ma anche così il risultato non riporta integralmente la musica scritta da Rossini: Pappano non disdegna, infatti, l’uso delle forbici (anche se con maggiore discrezione rispetto alle esecuzioni del 2006). La scelta appare molto spiacevole e del tutto ingiustificata: così poche sono le occasioni di ascolto che l’integralità dovrebbe essere un obbligo (oltretutto i minuti risparmiati sono – rispetto alle dimensioni dell’opera – poco più di una manciata, e insistono su pagine non meno che sublimi). Particolarmente sgradevole – a parte il taglio di alcuni brani di recitativo prima del divertissement dell’atto I e di qualche ripetizione nel coro che apre la seconda scena dell’atto III – è la completa eliminazione della scena quinta e sesta dell’atto IV: la preghiera di Hedwige e il terzetto che la precede. Peccato. Le cose vanno meglio dal punto di vista musicale: come Pappano intenda il Guillaume Tell, lo si capisce fin dalle prime battute della sinfonia, con l’abbandono lirico del violoncello solista, il suono vibrante, il gioco di rubati. Una visione pienamente “romantica”, agli antipodi del neoclassicismo spontiniano di Chailly e Muti. La natura, sottratta allo sfondo storico e resa protagonista musicale, irrompe nelle grandi scene corali, negli acquarelli del ranz des vaches, nella tempesta sul lago, nell’orgia “vitalistica” del galop che chiude la sinfonia o nei grandi finali d’atto (il primo e il secondo in particolare, mai così drammatico e teso, segnato da un incedere appena rallentato, ma incalzante), sino alla catarsi finale (l’inno alla libertà riconquistata e alla natura in trionfo) che chiude il cerchio di una partitura immensa come un’epopea. Anche ai ballabili – spesso trattati come mero décor – viene restituita una certa dimensione “sinfonica”, senza alcuna cessione alla frivolezza tipica del divertissement. Un’interpretazione, dunque, che non lascia indifferenti: forti contrasti e scelte radicali che, se possono far storcere il naso a certa intransigenza filologica, non mancano di affascinare l’ascoltatore. In questo Pappano è aiutato da un’orchestra splendida e da un coro semplicemente perfetto. Ma nell’opera, purtroppo, ci sono anche i cantanti: in questo caso principali colpevoli del risultato interlocutorio dell’incisione. Complessivamente accettabile il reparto maschile. Gerald Finley è, forse, uno dei migliori Guillaume Tell documentati su disco (in effetti la concorrenza non è molta): pur se si intuisce una certa carenza di volume nella voce e di autorità, si nota la ricchezza del fraseggio e il cesello del declamato (su cui si concentra la maggior parte della raffinatissima scrittura del personaggio, privo di una vera e propria aria). Il “Sois immobile!” è splendidamente cesellato (grazie anche all’apporto del violoncello solista di Gabriele Gemignani, già ottimo nella sinfonia). In ciò è aiutato da una buonissima conoscenza della prosodia francese. Lo stesso non si può dire dell’Arnold di John Osborn che, oltre ad una pronuncia farraginosa (che compromette e sporca la fluidità dei versi e il fraseggio – ridotto ad una specie di poltiglia), mostra più di una difficoltà con il colore e le mezze tinte: gli acuti suonano facili quando emessi di “poitrine”, ma tendono al falsetto nelle smorzature (la sezione centrale del duetto con Mathilde nell’atto II è impietoso esempio). La linea vocale, poi, appare spesso traballante e malferma. Certo la parte è di estrema difficoltà (leggere la “contabilità” degli acuti mette i brividi: 54 si bemolli, 15 si naturali, 19 do e due do diesis) e molto più complessa (nell’ambiguità espressiva che si traduce in un’alternanza di grandi espansioni liriche e scalate in acuto, giocando nelle zone più scomode della tessitura) di altri ruoli monstre (penso al Roul di Meyerbeer: recentemente affrontato dal medesimo interprete e con risultati più convincenti).
Si racconta che quando, nel luglio del 1860, Wagner incontrò Rossini nella sua villa di Passy, appena fuori Parigi, tra i vari discorsi in merito ai destini del teatro d’opera, osservò come, con il suo Guillaume Tell, avesse raggiunto un perfetto connubio tra parola e musica (in particolare si riferiva al “Sois immobile!”): a quel punto Rossini, divertito, chiese con sarcasmo “E così ho fatto musica dell’avvenire?”, “No Maestro! Avete fatto musica per tutti i tempi”. Purtroppo Wagner fu cattivo profeta: l’estremo capolavoro rossiniano, infatti, rimase musica per “nessun tempo”! Più ammirato e celebrato (addirittura innalzato a onori divini da un entusiasta Donizetti), che realmente compreso, il Guillaume Tell restò un modello mai compiutamente seguito, un unicum, un’opera “inattuale” (come avrebbe detto Nietzsche). Alle difficoltà formali si unirono ben presto i mutamenti di gusto (l’incombenza del romanticismo e l’avvento del dramma musicale) e le problematiche esecutive: in breve tempo l’opera – dopo una serie di rimaneggiamenti e riduzioni – sparì dalle scene e la sua compiuta riscoperta venne sempre rinviata a “momenti migliori”. Anche nel nostro secolo il titolo rimase poco frequentato o proposto in edizioni del tutto discutibili quanto a integrità testuale e stilistica, e affidato ad interpreti largamente inadeguati (fanno eccezione le poche renaissance degli ultimi anni): nei teatri come nelle sale d’incisione. Per tutto questo una nuova edizione del Guillaume Tell è un vero e proprio evento. Tanto più che – nel presente caso – viene eseguita (in edizione critica) la versione originale francese e non la cattiva traduzione ritmica del Bassi (che tanto danneggia la linea musicale rossiniana, con modifiche arbitrarie e sgradevoli alterazioni per “adattare” la lingua italiana ad una musica scritta appositamente sulla prosodia francese). Grande merito va dunque tributato ad Antonio Pappano che, a capo delle magnifiche compagini di Santa Cecilia, ha fortissimamente voluto l’operazione. Operazione che, purtroppo, passato l’iniziale entusiamo e dopo un ascolto approfondito, appare come un’occasione non pienamente colta, atteso l’esito deludente da parte di taluni interpreti e qualche dubbio sulle scelte testuali. L’incisione EMI (di qualità non eccellente peraltro: squilibrio voce/orchestra, qualche distorsione nelle frequenze più alte e, soprattutto, fastidiosa presenza di colpi di tosse et similia, a testimonianza della maleducazione del pubblico italiano, sempre più adatto ai “sanatori” che alle sale da concerto) è il frutto di un collage di concerti, registrati a Roma tra l’autunno e l’inverno del 2010: l’opera, eseguita in forma di concerto nell’autunno del 2010, era, infatti, privata dei divertissement di I e III atto, che sono stati incisi separatamente nel corso di alcuni concerti natalizi nel medesimo anno. Ma anche così il risultato non riporta integralmente la musica scritta da Rossini: Pappano non disdegna, infatti, l’uso delle forbici (anche se con maggiore discrezione rispetto alle esecuzioni del 2006). La scelta appare molto spiacevole e del tutto ingiustificata: così poche sono le occasioni di ascolto che l’integralità dovrebbe essere un obbligo (oltretutto i minuti risparmiati sono – rispetto alle dimensioni dell’opera – poco più di una manciata, e insistono su pagine non meno che sublimi). Particolarmente sgradevole – a parte il taglio di alcuni brani di recitativo prima del divertissement dell’atto I e di qualche ripetizione nel coro che apre la seconda scena dell’atto III – è la completa eliminazione della scena quinta e sesta dell’atto IV: la preghiera di Hedwige e il terzetto che la precede. Peccato. Le cose vanno meglio dal punto di vista musicale: come Pappano intenda il Guillaume Tell, lo si capisce fin dalle prime battute della sinfonia, con l’abbandono lirico del violoncello solista, il suono vibrante, il gioco di rubati. Una visione pienamente “romantica”, agli antipodi del neoclassicismo spontiniano di Chailly e Muti. La natura, sottratta allo sfondo storico e resa protagonista musicale, irrompe nelle grandi scene corali, negli acquarelli del ranz des vaches, nella tempesta sul lago, nell’orgia “vitalistica” del galop che chiude la sinfonia o nei grandi finali d’atto (il primo e il secondo in particolare, mai così drammatico e teso, segnato da un incedere appena rallentato, ma incalzante), sino alla catarsi finale (l’inno alla libertà riconquistata e alla natura in trionfo) che chiude il cerchio di una partitura immensa come un’epopea. Anche ai ballabili – spesso trattati come mero décor – viene restituita una certa dimensione “sinfonica”, senza alcuna cessione alla frivolezza tipica del divertissement. Un’interpretazione, dunque, che non lascia indifferenti: forti contrasti e scelte radicali che, se possono far storcere il naso a certa intransigenza filologica, non mancano di affascinare l’ascoltatore. In questo Pappano è aiutato da un’orchestra splendida e da un coro semplicemente perfetto. Ma nell’opera, purtroppo, ci sono anche i cantanti: in questo caso principali colpevoli del risultato interlocutorio dell’incisione. Complessivamente accettabile il reparto maschile. Gerald Finley è, forse, uno dei migliori Guillaume Tell documentati su disco (in effetti la concorrenza non è molta): pur se si intuisce una certa carenza di volume nella voce e di autorità, si nota la ricchezza del fraseggio e il cesello del declamato (su cui si concentra la maggior parte della raffinatissima scrittura del personaggio, privo di una vera e propria aria). Il “Sois immobile!” è splendidamente cesellato (grazie anche all’apporto del violoncello solista di Gabriele Gemignani, già ottimo nella sinfonia). In ciò è aiutato da una buonissima conoscenza della prosodia francese. Lo stesso non si può dire dell’Arnold di John Osborn che, oltre ad una pronuncia farraginosa (che compromette e sporca la fluidità dei versi e il fraseggio – ridotto ad una specie di poltiglia), mostra più di una difficoltà con il colore e le mezze tinte: gli acuti suonano facili quando emessi di “poitrine”, ma tendono al falsetto nelle smorzature (la sezione centrale del duetto con Mathilde nell’atto II è impietoso esempio). La linea vocale, poi, appare spesso traballante e malferma. Certo la parte è di estrema difficoltà (leggere la “contabilità” degli acuti mette i brividi: 54 si bemolli, 15 si naturali, 19 do e due do diesis) e molto più complessa (nell’ambiguità espressiva che si traduce in un’alternanza di grandi espansioni liriche e scalate in acuto, giocando nelle zone più scomode della tessitura) di altri ruoli monstre (penso al Roul di Meyerbeer: recentemente affrontato dal medesimo interprete e con risultati più convincenti).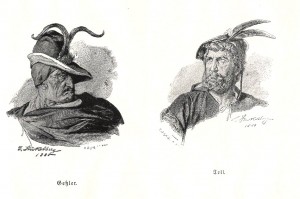 Certo, alla fine Osborn ne viene a capo (nel senso che esegue tutte le note…anche se non basta), ma la fatica è percepibile e il confronto con Gedda, Pavarotti e, soprattutto, Kunde (ad oggi la miglior incarnazione dell’Arnold rossiniano), neppure si pone! Ne è esempio la grande scena dell’atto IV: il recitativo iniziale è molto difficoltoso e pasticciato, così come l’aria “Asile héréditaire”, compromessa da una dizione e da un fraseggio arruffati (e da acuti in odor di falsetto); un po’ meglio la cabaletta, anche se lo sforzo è evidente (seppur la cattiva ripresa di casa EMI tenda a mettere la voce in secondo piano). Al contrario Celso Albelo, pur penalizzato da una pronuncia francese ancora peggiore di quella di Osborn (ma a Santa Cecilia non hanno un ripetitore linguistico?!), risolve con onore la difficile parte di Ruodi (molto buono lo squillo dell’aria iniziale e molto ordinata la linea vocale). Più squilibrato il Walter di Matthew Rose (che balla un po’ troppo nel terzetto). Il Gesler di Carlo Cigni esprime invece, in un francese turistico, i problemi legati ad un ruolo né protagonista né comprimario, accontentandosi di una discreta professionalità (che è già più di quel che normalmente tocca sentire). Discreti/buoni gli altri. Maggiori problemi si evidenziano nel reparto femminile: non tanto Marie-Nicole Lemieux e Helena Xanthoudakis (rispettivamente Hedwige e Jemmy), dato che, private delle due scene nell’atto IV, le parti si riducono a poco più di comprimarie (ma che pena gli “strilli” di Jemmy nel finale I!), quanto la protagonista. La Mathilde di Malin Bystrom è, infatti, pessima: acuti difficoltosi, centro traballante, agilità arruffate, fraseggio incespicato e perenne affanno (frutto, probabilmente, di una cattiva tecnica respiratoria). Con tali presupposti “Sombre fôret”, brano di difficile esecuzione e di carattere inafferrabile, che dovrebbe suggerire malinconie e struggimento (in un clima di preromanticismo spinto, sospeso tra realtà e sogno) è semplicemente uno strazio. Così come il duetto che segue (anche se i tecnici EMI, proprio dopo il duetto, lasciano furbescamente gli applausi della sala, tagliati, invece, al termine di tutti gli altri “numeri”, salvo l’aria del tenore). Non migliora certo nella prima parte dell’atto III. Tirando le somme questa nuova edizione del Guillaume Tell è l’ennesima occasione sprecata di un mercato discografico ormai in forte crisi d’identità. Un’incisione che difficilmente mi verrà voglia di riascoltare – nonostante la bella direzione di Pappano – e che non può ambire certo ad accostarsi a quelle di Chailly, di Gardelli e di Muti: sia per mancanza di interpreti credibili (con l’eccezione di Finley) sia per il livello tecnico (meglio sarebbe stato registrare l’opera durante le prove). Un ultimo accenno alla scadente presentazione grafica del cofanetto EMI: pessima scelta la copertina con il faccione di Pappano con la mela in testa trafitta dalla bacchetta (?), ancora più discutibile l’utilizzo della lingua inglese per il titolo (Rossini non ha scritto nessun William Tell!), di cattivissimo gusto, poi, la fotografia del Lone Ranger sul retro del libretto d’accompagnamento (come se la sinfonia del Guillaume Tell fosse associata unicamente alla sigla di quel vecchio telefilm yankee). Un consiglio? Passare oltre…
Certo, alla fine Osborn ne viene a capo (nel senso che esegue tutte le note…anche se non basta), ma la fatica è percepibile e il confronto con Gedda, Pavarotti e, soprattutto, Kunde (ad oggi la miglior incarnazione dell’Arnold rossiniano), neppure si pone! Ne è esempio la grande scena dell’atto IV: il recitativo iniziale è molto difficoltoso e pasticciato, così come l’aria “Asile héréditaire”, compromessa da una dizione e da un fraseggio arruffati (e da acuti in odor di falsetto); un po’ meglio la cabaletta, anche se lo sforzo è evidente (seppur la cattiva ripresa di casa EMI tenda a mettere la voce in secondo piano). Al contrario Celso Albelo, pur penalizzato da una pronuncia francese ancora peggiore di quella di Osborn (ma a Santa Cecilia non hanno un ripetitore linguistico?!), risolve con onore la difficile parte di Ruodi (molto buono lo squillo dell’aria iniziale e molto ordinata la linea vocale). Più squilibrato il Walter di Matthew Rose (che balla un po’ troppo nel terzetto). Il Gesler di Carlo Cigni esprime invece, in un francese turistico, i problemi legati ad un ruolo né protagonista né comprimario, accontentandosi di una discreta professionalità (che è già più di quel che normalmente tocca sentire). Discreti/buoni gli altri. Maggiori problemi si evidenziano nel reparto femminile: non tanto Marie-Nicole Lemieux e Helena Xanthoudakis (rispettivamente Hedwige e Jemmy), dato che, private delle due scene nell’atto IV, le parti si riducono a poco più di comprimarie (ma che pena gli “strilli” di Jemmy nel finale I!), quanto la protagonista. La Mathilde di Malin Bystrom è, infatti, pessima: acuti difficoltosi, centro traballante, agilità arruffate, fraseggio incespicato e perenne affanno (frutto, probabilmente, di una cattiva tecnica respiratoria). Con tali presupposti “Sombre fôret”, brano di difficile esecuzione e di carattere inafferrabile, che dovrebbe suggerire malinconie e struggimento (in un clima di preromanticismo spinto, sospeso tra realtà e sogno) è semplicemente uno strazio. Così come il duetto che segue (anche se i tecnici EMI, proprio dopo il duetto, lasciano furbescamente gli applausi della sala, tagliati, invece, al termine di tutti gli altri “numeri”, salvo l’aria del tenore). Non migliora certo nella prima parte dell’atto III. Tirando le somme questa nuova edizione del Guillaume Tell è l’ennesima occasione sprecata di un mercato discografico ormai in forte crisi d’identità. Un’incisione che difficilmente mi verrà voglia di riascoltare – nonostante la bella direzione di Pappano – e che non può ambire certo ad accostarsi a quelle di Chailly, di Gardelli e di Muti: sia per mancanza di interpreti credibili (con l’eccezione di Finley) sia per il livello tecnico (meglio sarebbe stato registrare l’opera durante le prove). Un ultimo accenno alla scadente presentazione grafica del cofanetto EMI: pessima scelta la copertina con il faccione di Pappano con la mela in testa trafitta dalla bacchetta (?), ancora più discutibile l’utilizzo della lingua inglese per il titolo (Rossini non ha scritto nessun William Tell!), di cattivissimo gusto, poi, la fotografia del Lone Ranger sul retro del libretto d’accompagnamento (come se la sinfonia del Guillaume Tell fosse associata unicamente alla sigla di quel vecchio telefilm yankee). Un consiglio? Passare oltre…
Gli ascolti:
Sinfonia: Fritz Reiner & Chicago Symphony Orchestra (1958)

“Ah! Mathilde, idole de mon âme!”: Gregory Kunde, Michele Pertusi (1995)

“Selva opaca”: Renata Tebaldi (1965)

“Sois immobile!”: Michele Pertusi (1995)

“Asile héréditaire”: Gregory Kunde (1995)

Finale: Riccardo Muti (1988)


Caro Duprez, proprio in questi giorni ho intrapreso l’ascolto del nuovo G. T. di Pappano, fortunatamente trovato in sconto a Parigi, dove mi trovo… pur non conoscendo bene quanto te la discografia, mi trovo sostanzialmente d’accordo: ieri sera ascoltavo la prima parte del terzo atto (è qui che sono arrivata nell’ascolto) e la cosa che più mi ha impressionato è per l’appunto il perenne affanno della povera Bystrom, che riprende fiato ogni tre per due. Non so te, ma a me sembra anche che la voce di Osborn sia perennemente nasale, e la linea vocale assai approssimativa nel rendere le agilità e la coloratura. A fronte di una lettura orchestrale interessante, l’interpretazione dei cantanti rende sostanzialmente una NOIA MORTALE questa edizione del Tell, privo com’è il canto di quel mordente e di quelle scintille vocali, di quel nitore e di quella levigatezza che il canto rossiniano dovrebbe avere per definizione. Complimenti, come al solito, per la precisione e per la bellezza della tua prosa, questa sì nitida ed efficace. Nei prossimi giorni, ascolterò il terzo disco, speriamo bene! A presto, MFM
Maria, riprendi il tuo nick originario, please.
Sono sostanzialmente d’accordo con quanto riportato nel bell’articolo di Duprez. Ero in sala sia in occasione del primo Tell di Pappano, sia nella seconda occasione romana e in entrambi i casi la direzione mi è parsa molto limpida, brillante, con tanti momenti di sublime poesia ma senza quel nerbo che pur Tell possiede. I cantanti non erano comunque all’altezza del concertatore: magnifico Pertusi nel primo Tell, debole dal vivo Finley, che indugiava spesso e volentieri al falsetto. E così Osborn, troppo fiacco e sdilinquito per una parte che ogni tanto vorrebbe pure un pò di voce in più, soprattutto più appoggiata. La Bylstroem, una “strafiga” certamente, ma nell’Opera non basta il piacere della vista: disastrosa nelle agilità e nella salita agli acuti, priva di una tecnica degna di tal nome. Ricordo che dal vivo finirono per fare un figurone Albelo e Bosi, tra i comprimari. Molto bene il Coro.
Mi fa piacere che adesso anche tu condivida le nostre obiezioni su J. Osborn ( ricordi il tuo post nel vecchio sito?). Non capisco perchè questo tenore che iniziato con prove stupende da contraltino puro ( e voce maschile per nulla eunucoide) si sia fatt prendere la mano dalla tuttologia per arrivare a squilibrare e danneggiare così il proprio canto. Osborn non è Gedda, non può seguire la sua via eclettica…..e sta pagando salato questo misunderstanding.
Completamente d’accordo: ciò che più meraviglia (in negativo) è la frammentarietà e l’instabilità della linea di canto, soprattutto nei momenti lirici (dove ci si attenderebbe maggiora attenzione alle sfumature). La voce, spesso, appare instabile e tende a spezzarsi ogni volta che abbandona il canto “spiegato”. Certo gli acuti ci sono (quelli di “poitrine”, perché per il resto abusa di falsetto). Ovviamente Arnold mette in luce tutti questi problemi, molto più di Raoul de Nangis (dove – patteggiando con i momenti più “elegiaci e lirici” – non ha mostrato problemi a reggerne la scrittura eroica). Altro aspetto – a mio avviso fondamentale – la questione della pronuncia: non è accettabile affrontare così la prosodia francese (a Bruxelles, forse anche per non sfigurare con gli autoctoni, era molto più curata). I versi del Guillaume Tell sono perfettamente calibrati sulla linea musicale e vocale (ecco perché la traduzione del Bassi è, più di altre, nefasta) e la resa perfetta della prosodia è condicio sine qua non per poter affrontare decentemente e con eleganza la parte (Gedda e Kunde, ad esempio, la padroneggiano): il francese di Osborn a Roma (come quello di Albelo e di altri interpreti) è, invece, orribile! Credo che questa mancanza di cura (e mi meraviglio che succeda a Santa Cecilia, che dovrebbe essere una delle eccellenze italiche) sia uno dei fattori principali del sostanziale fallimento di questa incisione del Tell.
I problemi di Osborn sopra descritti sono, purtroppo, emersi nell’ultima recita della Donna del Lago alla Scala…..
Ho una domanda. Prendiamo il ruolo di Aroldo. C’è una cosa che non capisco e che vorrei mi aiutaste a capire: chi è il tenore che canta questo ruolo? Mi spiego: Duprez, tu citi Gedda, Pavarotti e Kunde, ma una volta non era appannaggio di tenori come Tamagno? Il quale mi sembra di ben altro peso rispetto ai tre citati… Grazie!
certo! ….Raimondi… Lauri Volpi…etc
Ops! Giulia, non avevo visto la tua risposta: chiedo venia!
Ecco tu invochi Lauri Volpi, ma temo che Giacomino fosse un unicum nel suo genere. E temo che lo stampino fu perso, e non gettato, con sommo dispiacere del Demiurgo.
A dirla tutta Tamberlick che ci importa di quel che cantava Tamagno, atteso che il ruolo non è certo stato costruito sulla sua voce e sul suo stile? Tamagno appartiene ad una generazione di cantanti che non cantava più con regolarità Rossini, e soprattutto certo Rossini. A parte, poi, che non era certo un tenore “muscolare”, il problema è individuare la vocalità della prima metà dell’800 e considerare quanto divergesse da quella della fine del secolo. Tamagno viene dopo la parabola verdiana e wagneriana, quando i parametri stilistici mutano radicalmente. La riscoperta del Tell (inteso rettamente e non come opera paraverdiana) è recente e non si può certo confrontare con certe esibizioni passate che hanno un valore puramente storico. Per cantare Arnold non occorre una voce di tonnellaggio, ma un cantante dotato di estrema facilità d’acuto, fraseggio immacolato e tenuta di fiato: Gedda e Kunde ben interpretano l’evoluzione del contraltino rossiniano (già tradotto in cifra preromantica), Pavarotti si ammira per la voce (anche se latita l’interprete), altro non è pervenuto….salvo selezioni più o meno estese della parte con notevoli patteggiamenti ed alterazioni. Del resto basta considerare per quale tipologia di tenore viene scritto Arnold: Nourrit (in prima istanza) e più tardi Duprez (con cui cambia la tecnica d’emissione degli acuti: dal falsettone alla voce di “poitrine” ….per semplificare). In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di cantanti belcantisti, fraseggiatori (non a caso protagonisti dei principali grand opéra). Arnold è parente di Raoul de Nangis, non certo dell’Otello verdiano…parlo principalmente di stile, non di peso vocale.
Ps: non definirei tenori leggeri Gedda, Kunde o Pavarotti (hai presente che repertorio affrontavano?)…alla stessa stregua di un Florez.
Innanzitutto ti ringrazio per la tempestiva ed esaustiva risposta.
Cominciando dal tuo post scriptum, beh di certo io non li definisco tali. Poi mi sbaglierò, ma dopo tutto penso che la nomenclautra che tassonomizza le voci sappia un po’ di idealtipo, con tutto ciò che ne consegue. Mi sembra però plausibile che un Tamagno fosse un “filo” più tonitruante di un Gedda.
Posso concordare su Kunde come evoluzione diretta del contraltino rossiniano; Gedda…. mah… lo vedo un po’ più eclettico.
Ti confesso, infine che la mia domanda era un filo interessata: il richiamo a Tamagno e, volendo, forse anche al tenore cui ho preso in prestito il nome volevano essere un disperato tentativo di far rientrare la categoria delle voci di tonnellaggio a cantare ruoli di questo genere. Ma sono ben conscio che subentri anche un discorso di tessitura, oltre a quello relativo all’estensione.
Ti rispondo con una domanda: ma troveresti ancora plausibile (soprattutto stilisticamente) un Arnold torniturante?
No. Però, però un pochino più eroico di un Gedda o di un Kunde sì. Con la qual cosa non voglio togliere loro nulla: tanto meno il ruolo di Arnold.
Beninteso, non ritengo plausibile che si canti Arnold con voce di heldentenor o con voce baritonale però mi chiedevo se non fosse possibile un connubio tra Arnold e una voce drammatica che non fosse un ossimoro.
Un Martinelli?
E’ una parte da contraltino. L’ideale poi sarebbe un contraltino con timbro argentino e squillo eroico. Lauri Volpi o Tamagno erano voci ideali per questo tipo di repertorio. Tra i francesi l’esempio che mi viene in mente è Escalais. Tra i cantanti di area tedesca, un Leo Slezak…
Youtube offre ascolti molto interessanti e preziosi:
http://www.youtube.com/watch?v=fPQgaX86l3w
http://www.youtube.com/watch?v=RhcHVrSD39g
http://www.youtube.com/watch?v=gEIQgSXYVDw
http://www.youtube.com/watch?v=L1jB7sDxgI4
Infatti, non capisco perché si dovrebbe far cantare una parte di tenore contraltino ad un’altra voce.
Fino a un certo punto: non danno certo l’idea di come affrontassero l’intera opera… Sono pezzi svincolati eseguiti in ambito del tutto diverso. Comunque Lauri-Volpi è davvero dimenticabile…a cominciare dal solfeggio; Slezak ha timbro magnifico (ma lo trovo molto ingessato nel fraseggio e impacciato in certi respiri); Escalais nel complesso il migliore (anche se l’ascolto di un brano isolato non dice nulla); Tamagno è, per me, incomprensibile (qualità precaria di registrazione non rende certo onore a quello che è tramandato come tenore storico)
Secondo me le caratteristiche vocali di Arnold sono ben definite: si tratta dell’evoluzione del contraltino rossiniano post “cura” francese, che ha provveduto a “sgrassarne” l’eccessiva coloratura a favore di un lirismo più espressivo. Evoluzione di Arnold è il tenore da grand opéra: Raoul de Nangis (anche se più “semplificato”). Su questa radice si innesta l’evoluzione tecnico/stilistica che ha portato ad abbandonare (parzialmente) il cosiddetto falsettone, sostituito con un’emissione “de poitrine” per gli acuti (con buona pace di Rossini). E’ il percorso che porta da Nourrit a Duprez: anche se non bisogna pensare a quest’ultimo come ad un tenore “urlatore” o testosteronico, semplicemente eseguiva “di forza” e “di petto” certe note che prima erano raggiunte “di testa”. Ma la dimensione estetica del personaggio – tipica del classicismo rossiniano – non muta di molto: Arnold è un personaggio di lirica malinconia, che ha poco dell’eroe (e quando ne assume le vesti, lo fa nella forma idealizzata e astratta, tipica del primo grand opéra). Il dramma, come lo intendiamo noi (e che ben può essere identificato con alcune delle voci citate da te o da Giulia), in ottica verdiana o post verdiana, è dimensione estranea a Rossini. L’ossimoro lo troverei proprio qui: nell’unire il nostro dramma con l’estetica rossiniana (che nell’opera seria, resta tragica, che è cosa ben diversa, e sostanzialmente antiromantica).
La mera prospettazione della “possibilità” di un Arnold “forzuto” deriva dal fraintendimento del Guillaume Tell da parte delle generazioni a cavallo tra ‘800 e ‘900 (quelle di cui restano sporadiche testimonianze): grave danno hanno recato all’opera! Innanzitutto attraverso riduzioni, semplificazioni e rimaneggiamenti l’hanno trasformata in qualcosa di estremamente diverso; poi lo spingere su preteso carattere preverdiano e risorgimentale, ha dato il “colpo fatale” fraintendendone COMPLETAMENTE stile, estetica e vocalità. Atteso che quel che all’epoca si cantava ben poco aveva a che fare con la musica di Rossini.
Io credo che sia del tutto inutile alambiccarsi con immaginarie interpretazioni (sottoposte a innumerevoli “ipotetiche”: di stile, integralità, estetica etc..). La parte di Arnold è scritta e le testimonianze d’epoca sono inequivocabili, così come gli intendimenti dell’autore. Ad oggi gli unici cantanti che l’hanno cantata integralmente e con competenza stilistica restano (piaccia o meno) Gedda, Kunde, Merritt e, in parte, Pavarotti: come l’avrebbero cantata Martinelli o Lauri Volpi o Tamagno è cosa che né mi scalda né mi interessa un granché. Così come non si può sbracare come Turiddu cantando Arturo dei Puritani, allo stesso modo non trovo concepibile un Arnold “muscolare”, salvo travisarne completamente il senso musicale. Certo l’hanno cantato Bonisolli e Filippeschi (ma con ogni genere di raggiusto), ma non me la sentirei di indicarli come modelli stilistici.
Peraltro bisognerebbe anche considerare che una parte scritta per un tenore contraltino vada cantata da un tenore contraltino, anche perché se affrontata da altri tipi di voci potrebbe presentare seri ostacoli.
Ricordo, infine, che la parte di Arnold sfoga costantemente in acuto ed insiste nelle zone più acute della tessitura – non certo sul corpo centrale (sfruttato invece dai tenori drammatici) – e, dal momento che non esistono in natura “voci assolute” per cui si può adattare tutto il repertorio, mi chiedo come un tenore drammatico possa sostenere INTEGRALMENTE (l’incisione della singola aria non vuol dire assolutamente nulla) una parte che impone (ripeto) 54 si bemolli, 15 si naturali, 19 do e due do diesis!!! Che si fa? Si tagliano? Si torna agli scempi di un tempo? Non sarebbe meglio che i tenori drammatici cantassero le loro parti?
Quelli che ho citato sono tutti esempi di contraltini. Contraltino non significa necessariamente “leggero”, o come si una in gergo, “zanzara”. Tamagno era un tuono, Lauri Volpi pure, ed erano contraltini. “Contraltino” è una classe vocale, come tenore, baritono, basso… poi all’interno di quella classe, come di ogni altra classe, si possono fare ulteriori classificazioni, e quindi abbiamo il tenore drammatico, il lirico, il leggero, il baritono brillante e il baritono drammatico, il basso cantante ed il profondo, e così la classe del contraltino (che è la voce maschile più acuta) presenterà al suo interno voci diverse per timbro, spessore, estensione… Per il grand-opéra ritengo che l’ideale sia una voce come quella di Lauri-Volpi. Un secolo fa il grand opéra era ancora di repertorio, ed era appannaggio di voci importanti (contraltini come Tamagno, ad esempio). Nel Dopoguerra Pavarotti sarebbe stato l’ideale, certo con tutt’altra saldezza tecnica, giacché se non sei perfetto, queste sono opere che ti ammazzano (vedi Merritt).
Sì sì, sono d’accordo, ma con alcune precisazioni: il grand opéra era sì in repertorio, ma stilisticamente assai lontano da come era concepito. I molti tagli, gli adattamenti (spesso assai discutibili), la perdita di molti elementi necessari alla sua comprensione, ne mortificavano di molto la natura e la struttura. Certo rimanevano le esibizioni dei singoli nelle parti rimaste: inutile ricapitolare come il Tell venne trattato o i tagli forsennati a Huguenots e Juive… Insomma il grand opéra è genere tutto da riscoprire e da reinventare. E non solo soffermandosi sui cantanti, che sono solo una parte… Ci sono opere che adattate e rimodellato mostrano tutte quelle debolezze che, rappresentate integralmente, non rivelano. A Bruxelles, ad esempio, avendo la fortuna di ascoltare il finale II nella sua forma integrale, mi sono reso conto di quanto fosse sgradevole il moncone che ne fa Bonynge. Purtroppo i cambiamenti di gusto hanno sostanzialmente condannato il grand opéra all’oblio e ne hanno impedito una sua coerente riproposizione…peccato perché con certi cantanti sarebbe stato un autentico piacere.
D’accordo, ma è un repertorio che è sopravvissuto finché ci sono state le voci in grado di eseguirlo, oggi non esiste più, ascoltare queste opere a teatro è rarissimo o impossibile, certo anche io auspico che avvenga una riscoperta, ma c’è il problema delle voci. Escalais, Augustarello Affre, Tamagno, ed infine Lauri Volpi, erano gli ultimi esponenti di quella tradizione tenorile che cominciava con Nourrit e Duprez, e che poi con il Novecento si è interrotta.
Erano gli ultimi specialisti di quel repertorio, prima che scomparisse.
Mi permetto di riprendere un approfondimento di Donzelli sull’argomento, in un vecchio post, per chi volesse rileggerlo:
http://www.ilcorrieredellagrisi.eu/2008/07/il-tenore-prima-di-caruso-e-del-verismo-parte-vii/
Secondo me si è interrotta ben prima del ‘900…è cambiato gusto e atteggiamento: quello che facevano al Met (ad esempio) era più o meno un surrogato… Certo dici giustamente che ci vogliono cantanti con determinate caratteristiche (oggi, anche per evoluzioni di repertorio, si è persa dimestichezza con quel genere di canto: tra ‘800 e ‘900, invece, la formazione era ancora ottocentesca), ma soprattutto ci vuole una certa mentalità, un certo gusto per una forma teatrale che potrebbe apparire “eccessiva”. Il grand opéra pone seri problemi esecutivi:
– cantanti a cui è richiesta resistenza ed estrema perizia (le parti sono spesso difficilissime)
– riflessione stilistica, perché si dovrebbe anche “credere” nel grand opéra e non prenderlo a pretesto per trasformarlo in Verdi o in Wagner
– elevato numero di ruoli in cui spesso è difficile distinguere prime e seconde parti
– necessità di un direttore capace di dare senso e unità ad un materiale molto vasto
– orchestre al di sopra della media
– regia che non si limiti a noiosi concerti in costume né che colga l’occasione per imporre rivisitazioni improbabili…per intenderci un Pizzi (che trasforma qualsiasi cosa tocchi in un potente anestetico) sarebbe quanto di peggio possa capitare. Occorre teatro, teatro, teatro…
Escalaïs cantò fino al ’91 all’Opéra di Parigi, ed era specializzato in opere come Guglielmo Tell (che cantò al suo debutto, e vent’anni dopo al suo ritorno nel teatro), Roberto il Diavolo, Ugonotti, Ebrea, Africana, e poi in altri titoli come Faust, Sigurd, Trovatore. Non mi risulta abbia mai cantato al Met (che comunque al tempo aveva un pubblico molto esigente in fatto di voci: vi cantava Jean de Reszke). Le stesse considerazioni valgono per Augustarello Affre, e per diversi altri cantanti francesi di quel periodo, che frequentavano lo stesso repertorio, e di cui ci rimangono testimonianze fonografiche (Alvarez, Vaguet, Scaramberg…). Quei cantanti furono gli ultimi a costruire la carriera su quei titoli, tenendoli stabilmente nel proprio repertorio.
Duprez, premesso che il mio intento era solo di voler capire ed aggiustare magari un poco le mie opinioni, mi pare, a meno che vari siti (e non solo la vituperata Wikipedia) che almeno i tre: Martinelli, Lauri Volpi e Tamagno, portassero in teatro il Tell. E pure Ugonotti. Per carità lo affermo senza essermi letto monografie su nessuno dei 3 quindi magari si tratta anche di errori. E con maggior carità può darsi che effettivamente fossero completamente fuori stile: io questo non lo so, ché non ho la vostra competenza; tuttavia mi hai dato materiale per riflettere e te ne ringrazio.
Grazie anche a Mancini per avermi segnalato gli ascolti… Effettivamente anche io come te pensavo che quelle fossero voci molto adatte a Tell, come Ugonotti, Profeta e compagnia briscola…
Infine chiedo anche un po’ di venia se c’è stata da parte mia una certa insistenza: spesso si ama di più ciò che non si può fare.
Ma certo che erano voci adatte, era il loro repertorio caspita!
Che portassero a teatro il Tell non significa nulla: bisogna vedere quale Tell portavano a teatro…ossia quanto ampia fosse la selezione, giacché tra tagli aggiusti e rimaneggiamenti della musica di Rossini restava ben poco. Ecco perché ogni nuova incisione o esecuzione del Guillaume Tell è un evento.
Ps: anche Bonisolli l’ha portato in scena…..